“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.” Antonio Gramsci
30 aprile 2024
IL PRIMO MAGGIO E LA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE VISTI DA V. MAJAKOVSKIJ
ABBIAMO TUTTI UN DEBITO CON FRANCESCO CARBONE
Oggi sul bel bimestrale DIALOGHI MEDITERRANEI viene pubblicato un mio articolo in cui analizzo i rapporti tra FRANCESCO CARBONE, GIACOMO GIARDINA e RENATO GUTTUSO:
Costruire una cultura nuova. La lezione di Francesco Carbone
di Francesco Virga
Abbiamo tutti un debito con Francesco Carbone. Non abbiamo compreso fino in fondo il senso della sua opera. Ed io stesso, pur avendo avuto l’opportunità di incontrarlo e vederlo spesso, non sempre mi ritrovavo nelle mille cose che faceva. Ma c’era una cosa che mi colpiva particolarmente ed era la cosa che più mi piaceva di Ciccino: era la sua straordinaria capacità di ascolto e di dialogo che mostrava sia con i contadini e i pastori analfabeti di Godrano (PA) che con i grandi intellettuali del suo tempo. La bussola di Francesco Carbone – dalle sue prime iniziative a Godrano contro la prepotenza mafiosa dell’ultimo dopoguerra fino alla creazione di GODRANOPOLI – è stata sempre questa: unire basso e alto, ossia cercare un punto d’incontro tra le mille forme della cultura delle classi subalterne e la cultura dei grandi intellettuali europei. Ma, come voleva Gramsci, non per abbassare la cultura degli intellettuali ma per trasformare la cultura di tutto il popolo.
Ciccino ha lavorato e lottato sempre per costruire una nuova cultura aperta a tutti, convinto che la cultura privilegio esclusivo di una élite fosse una cattiva cultura. Carbone, da geniale autodidatta, non aveva alle spalle studi sistematici, leggeva tanto ed era curioso di tutto. Ed anche se aveva letto poco Gramsci respirava nell’aria degli anni sessanta e settanta tanti motivi e temi gramsciani. Lo dimostra quella sorta di Manifesto, pubblicato a Palermo nel 1968, in uno straordinario numero unico di Presenzasud, nato come Periodico di cultura contemporanea, edito dal Centro di ricerche estetiche NUOVA PRESENZA.
 È stato davvero non facile riuscire a fare a Palermo una rivista capace di mettere insieme pezzi di Giulio Carlo Argan, Maurizio Calvesi, Paolo Emilio Carapezza, Gillo Dorfles, Achille Bonito Oliva, Gioacchino Lanza Tomasi, Crescenzio Cane, Gaetano Testa e Michele Perriera. Ma, come tante altre sue iniziative, purtroppo non ha avuto un seguito. La rivista, infatti, è rimasta numero unico in attesa di registrazione. Francesco Carbone, in qualità di Direttore della rivista, firmava, insieme a tanti altri pezzi, l’editoriale intitolato in modo provocatorio “Presenzasud e l’orinale di Don Fabrizio”. Un testo ben articolato ed argomentato che metteva in discussione tanti luoghi comuni e, principalmente, il pessimismo e il fatalismo dell’autore del Gattopardo che negava alla Sicilia la possibilità di qualsiasi cambiamento. Nel passo centrale affermava:
È stato davvero non facile riuscire a fare a Palermo una rivista capace di mettere insieme pezzi di Giulio Carlo Argan, Maurizio Calvesi, Paolo Emilio Carapezza, Gillo Dorfles, Achille Bonito Oliva, Gioacchino Lanza Tomasi, Crescenzio Cane, Gaetano Testa e Michele Perriera. Ma, come tante altre sue iniziative, purtroppo non ha avuto un seguito. La rivista, infatti, è rimasta numero unico in attesa di registrazione. Francesco Carbone, in qualità di Direttore della rivista, firmava, insieme a tanti altri pezzi, l’editoriale intitolato in modo provocatorio “Presenzasud e l’orinale di Don Fabrizio”. Un testo ben articolato ed argomentato che metteva in discussione tanti luoghi comuni e, principalmente, il pessimismo e il fatalismo dell’autore del Gattopardo che negava alla Sicilia la possibilità di qualsiasi cambiamento. Nel passo centrale affermava:
«Vogliamo una cultura che non sia più di élite. Causa di crescente debolezza per la cultura – […] – è stato sempre l’isolamento delle élites, così che l’élite politica, quella filosofica, l’artistica, la scientifica sono separate, con gran danno di ciascuna non solamente per l’arresto di qualsiasi circolazione delle idee, ma per la mancanza di quei contatti e reciproci impulsi che sono importanti quanto le idee. Posta in termini di cultura e potere, di cultura e politica, sarebbe necessario che la politica fosse essa stessa cultura» (Francesco Carbone, Presenzasud, Palermo 1968: 2, corsivo mio).
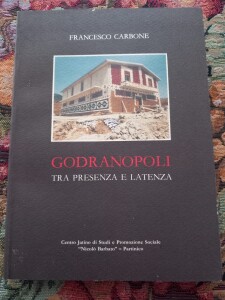 In questo editoriale c’è tutto il Gramsci di Francesco Carbone. Ha scritto tanto Ciccino ma non sempre la sua scrittura appariva chiara ai miei occhi. Ad esempio, il libro Godranopoli tra presenza e latenza del 1990, ad una prima lettura, non mi convinse per il frequente rimando a termini tecnici dell’arte contemporanea e ad autori che non conoscevo. La verità è che, malgrado le sue forti radici nella cultura agro-pastorale godranese, Francesco Carbone sapeva anche usare il linguaggio per iniziati della critica d’arte contemporanea.
In questo editoriale c’è tutto il Gramsci di Francesco Carbone. Ha scritto tanto Ciccino ma non sempre la sua scrittura appariva chiara ai miei occhi. Ad esempio, il libro Godranopoli tra presenza e latenza del 1990, ad una prima lettura, non mi convinse per il frequente rimando a termini tecnici dell’arte contemporanea e ad autori che non conoscevo. La verità è che, malgrado le sue forti radici nella cultura agro-pastorale godranese, Francesco Carbone sapeva anche usare il linguaggio per iniziati della critica d’arte contemporanea.
Una esemplare sintesi del suo concetto di cultura si trova in un magnifico manifesto creato dallo stesso Ciccino nel 1984 in occasione di una iniziativa ideata e realizzata nella sede dell’Opera Universitaria di Palermo presso il Pensionato S. Saverio dell’Albergheria. Ecco cosa ha scritto recentemente Rosella Corrado al riguardo:
«Di Godranopoli ho un altro ricordo tangibile, un manifesto che fu prezioso dono fattomi da Ciccio. All’interno di un elaborato cartiglio dell’Università degli studi di Palermo (con timbro e firma del direttore dell’Opera universitaria) una imperiosa freccia indirizza verso Godrano e il Centro Studi e documentazione Godranopoli. Godranopoli campeggia nella parte inferiore del manifesto con le parole chiave: “Immagini segni e momenti della comunicazione territoriale”. Il timbro del Centro e la firma autografa di Francesco Carbone sono posti accanto all’impronta digitale e al segno di croce di tal… Giuseppe fu Francesco residente a Godrano. Questo manifesto mi sembra una sintesi perfetta dell’idea di Cultura di Carbone, senza barriere e compartimenti stagni, senza gerarchie, ma basata sulla comunicazione, la circolarità e l’interconnessione dei saperi» [1].
Era questa l’idea di cultura che aveva Ciccino. E rientra perfettamente in questo quadro il recupero miracoloso che riesce ad operare del poeta pecoraio Giacomo Giardina (1901 -1994). La prima scoperta di Giardina, come è noto, si deve a Filippo Tommaso Marinetti. Non si sa bene come, ma è stato proprio il padre del futurismo italiano a presentarlo alla Ia Mostra Siciliana del Sindacato Fascista di Belle Arti svoltasi a Palermo il 3 aprile 1928. Se Marinetti non avesse intravisto nei versi del Giardina una singolare incarnazione del suo credo poetico, Giacomino, come lo chiamavano i suoi compaesani, sarebbe rimasto un venditore ambulante e uno dei tanti poeti contadini ignorati e dimenticati da tutti. Anche se la critica ha successivamente considerato riduttiva e forzata l’interpretazione del Marinetti, bisogna riconoscere che Giardina deve gran parte della sua libertà espressiva e del suo spirito antiaccademico al movimento futurista.
 D’altra parte il futurismo, nel suo versante artistico, al di là della deriva politica fascista che ebbe in Italia, nel resto del mondo conobbe sviluppi progressisti. Non a caso Trockij e Majakovskij, colpiti da un articolo giovanile di Antonio Gramsci, seguirono con simpatia le prime fasi del movimento futurista italiano.
D’altra parte il futurismo, nel suo versante artistico, al di là della deriva politica fascista che ebbe in Italia, nel resto del mondo conobbe sviluppi progressisti. Non a caso Trockij e Majakovskij, colpiti da un articolo giovanile di Antonio Gramsci, seguirono con simpatia le prime fasi del movimento futurista italiano.
C’è voluto un maieuta come Francesco Carbone per risvegliarlo da un lungo letargo. Infatti dopo la pubblicazione del suo primo libro Quand’ero pecoraio. Liriche, avvenuta nel 1931 per i tipi della Vallecchi di Firenze, una delle principali case editrici del tempo, Giacomo Giardina si chiude in un lungo silenzio. Questo libro, opportunamente ristampato in copia anastatica nel 2006, arricchito da una bella nota introduttiva di Anna Maria Ruta, merita qualche altra considerazione. È Rocca Busambra la principale musa ispiratrice di Giacomo Giardina. Il libro, infatti, è dedicato «alla montagna natia, seminata di pecore, che mi ha reso poeta»: è questa la vera dedica del poeta le altre – al Duce e a F. T. Marinetti – sono dovute alle circostanze temporali.
Come si sa, anche Ciccino Carbone ha amato Rocca Busambra insieme alla sua Godrano dove ha voluto essere sepolto. E il fondatore di Godranopoli non poteva ignorare il posto privilegiato che occupa la natura nella vita e nell’opera di Giardina. D’altra parte, il poeta pecoraio ha sperimentato sulla propria pelle i cicli naturali della vita e della morte, provando anche da vivo la morte. Il poeta, infatti, ha vissuto come una forma di morte l’afasia e l’arresto del proprio spirito creativo, influenzato probabilmente anche dal difficile confronto col nuovo astro nascente nel panorama poetico dell’ultimo dopoguerra: Ignazio Buttitta.
 Francesco è riuscito a risvegliare la vena poetica del poeta pecoraio, ridotto a fare il venditore ambulante di cianfrusaglie, ridandogli fiducia e aiutandolo a pubblicare le sue nuove creazioni. Si deve, infatti, a Carbone la seconda fioritura della poesia di Giacomo Giardina. In essa torna l’immagine di Rocca Busambra, come grande ventaglio di pietra. Una parte di queste sue nuove composizioni vennero raccolte in un prezioso volume, sapientemente curato da Nicolò D’Alessandro: Giacomo Giardina, Rocca Busambra. Poesie Disegni Testimonianze, Edizione Movimento Comunità di Base, Godrano-Palermo 1978, che si apre con un acuto «rilevamento antropologico culturale» dell’infaticabile Ciccino. Francesco Carbone ha saputo cogliere un aspetto dell’opera del Giardina ignorato da tanti altri critici:
Francesco è riuscito a risvegliare la vena poetica del poeta pecoraio, ridotto a fare il venditore ambulante di cianfrusaglie, ridandogli fiducia e aiutandolo a pubblicare le sue nuove creazioni. Si deve, infatti, a Carbone la seconda fioritura della poesia di Giacomo Giardina. In essa torna l’immagine di Rocca Busambra, come grande ventaglio di pietra. Una parte di queste sue nuove composizioni vennero raccolte in un prezioso volume, sapientemente curato da Nicolò D’Alessandro: Giacomo Giardina, Rocca Busambra. Poesie Disegni Testimonianze, Edizione Movimento Comunità di Base, Godrano-Palermo 1978, che si apre con un acuto «rilevamento antropologico culturale» dell’infaticabile Ciccino. Francesco Carbone ha saputo cogliere un aspetto dell’opera del Giardina ignorato da tanti altri critici:
«Il lavoro di Giardina contiene […] forti cariche di sobillazione, una ironia sottile e provocatoria, le quali si incaricano di sommuovere dalla base le lunghe fissità dei contesti agro-pastorali in cui la sua poesia è nata ed è cresciuta; di scuotere i precedenti ristagni e gli attuali ibridi conformismi della cultura contadina, i cui valori e la cui memoria sono sempre state le ragioni portanti della scrittura di Giardina» [2].
Questo straordinario quaderno-libro – ennesima creatura del geniale Francesco Carbone – è arricchito da alcuni preziosi disegni e testimonianze di Renato Guttuso e di altri artisti che hanno conosciuto il poeta. Sui rapporti tra Giacomo Giardina e Renato Guttuso ci sarebbe tanto da dire. Nel riservarmi di tornarci in un’altra occasione, in questo spazio mi limito a ricordare brevemente una lettera del pittore al poeta del 16/12/1974 in cui si afferma:
«Caro Giacomo, fin dall’ormai lontana adolescenza ho imparato ad amare la tua poesia, la fresca indipendenza della tua immaginazione, il tuo sentimento della natura e della gente umile. Ricordo brani bellissimi di un tuo romanzo che meriterebbe di vedere la luce. A te, al tuo lavoro, è legato uno dei miei primi dipinti (del ’28, mi pare) che ti raffigurava davanti alla tua Rocca Busambra, circondato dalle pecorelle. Dove sia quel quadro non si sa, ma ho fiducia che prima o poi salterà fuori» (ivi: 10).
 La lettera di Guttuso – che si chiude con uno schizzo del pittore in cui è abbozzato l’antico ritratto – è importante anche per il riferimento ad un “romanzo” inedito del poeta di cui si sono perse le tracce.
La lettera di Guttuso – che si chiude con uno schizzo del pittore in cui è abbozzato l’antico ritratto – è importante anche per il riferimento ad un “romanzo” inedito del poeta di cui si sono perse le tracce.
Lo stesso Francesco Carbone nel 1971 aveva curato un libretto che cercava di mettere a fuoco i rapporti artistici tra Giardina e Guttuso. In esso, oltre alla riproduzione di foto e disegni del grande pittore, veniva pubblicato un lungo poema del Giardina che dava anche il titolo alla pubblicazione: Guttuso nel mio quadro [3].
Un altro documento prezioso – che testimonia la lunga e profonda amicizia che ha legato i due artisti – è la lettera di Guttuso a Giardina del 22 giugno 1972, dove si afferma:
«Caro Giacomo, Quanti anni sono passati dal tempo in cui dipinsi il tuo ritratto! Sullo sfondo c’era Rocca Busambra, e pecorelle al pascolo, mentre tu declamavi al vento poesie, […]. Cosa è cambiato da allora? Molto dall’esterno, ma ‘di dentro’ poco o nulla. Battiamo sempre lo stesso chiodo, quello che ci siamo portati addosso dalla nascita, forse con più esperienza e sapienza, forse con meno freschezza. Ma in fondo anche con freschezza perché il nostro amore della verità e della realtà è un amore che non può finire» [4].
Altri testi del Giardina vengono pubblicati successivamente nell’antologia Dante ambulante al mio paese, Ila Palma, Palermo 1982; nel bel volume, curato da Nicolò D’Alessandro, per i tipi de La Bottega di Hefesto, Palermo 1991 e nella raccolta di scritti inediti e varianti (1928-1980), intitolata La corona di latta, curata da Aldo Gerbino (IPSA Editore, Palermo 1995).
Non può sorprendere, pertanto, che Francesco Carbone, dagli anni settanta in poi, vada in giro per la Sicilia accompagnato da Giacomo Giardina e che lo si ritrovi sempre accanto nel suo generoso tentativo di animazione socio-culturale della comunità godranese e del territorio circostante.
Tanti non hanno ben compreso la centralità che assume in tutta l’opera di Ciccino la creazione di GODRANOPOLI. Forse anche per questo abbiamo assistito passivamente alla sua chiusura e al suo abbandono, dopo la prematura morte del fondatore. Oggi sono più che mai convinto del fatto che, se non riusciremo a riaprire Godranopoli, tutto quello che abbiamo fatto finora per ricordarlo sarà inutile.
Dialoghi Mediterranei, n. 67, maggio 2024
Note
[1] R. Corrado, Sui quadri segreti di Francesco Carbone, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 61, maggio 2023.
[2] F. Carbone, Rilevamento antropologico culturale, in Giacomo Giardina, Rocca Busambra. Poesie Disegni Testimonianze, Edizione Movimento Comunità di Base, Godrano-Palermo 1978 : 9.
[3] Guttuso nel mio quadro. Giardina immagine e parola a cura di Francesco Carbone, edizioni centro di cultura interdisciplinare, Palermo 1971.
[4] Il testo integrale di questa lettera si trova nella “Monografia del poeta Giacomo Giardina” a cura della Galleria d’arte Valguarnera, Bagheria 1972. Il libretto, che comprende anche un pezzo di Francesco Carbone, si chiude con una nota sottoscritta da G. Giardina in cui si annuncia un nuovo volume di poesie intitolato Tempi incatenati opposti, con disegni di Guttuso. Di Guttuso va ricordata anche una sua pagina di diario: «Un artista parla solo delle cose che conosce, delle cose che sa, delle cose con le quali ha vissuto una comunione profonda da sempre, da quando non era neppure cosciente. Quindi il mio legame con la Sicilia è così profondo che viene fuori. Pirandello ha raccontato i pettegolezzi della farmacia di Porto Empedocle e sono stati capiti in Alaska o in Giappone. Quando si dice qualche cosa di vero, di profondo, questo diventa sempre universale. Il cuore umano ha una parte universale» (Renato Guttuso, da una pagina di diario pubblicata dal grande pittore in una rivista comunista del 1960).
______________________________________________________________________________
Francesco Virga, laureato in storia e filosofia con una tesi su Antonio Gramsci nel 1975, fino al 1977 lavora con Danilo Dolci nel Centro Studi e Iniziative di Partinico. Successivamente insegna Italiano nelle scuole medie della provincia di Palermo. Nel 1978 crea il Centro Studi e Iniziative di Marineo che continua ad animare anche attraverso un blog. È stato redattore delle riviste «Città Nuove», «Segno» e «Nuova Busambra». Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Il concetto di egemonia in Gramsci (1979); I beni culturali a Marineo (1981); I mafiosi come mediatori politici (1986); Cosa è poesia? (1995); Leonardo Sciascia è ancora vivo (1999); Pier Paolo Pasolini corsaro (2004); Giacomo Giardina, bosco e versi (2006); Poesia e storia in Tutti dicono Germania Germania, di Stefano Vilardo (2010); Lingua e potere in Pier Paolo Pasolini (2011); Danilo Dolci quando giocava solo. Il sistema di potere clientelare-mafioso dagli anni cinquanta ai nostri giorni (2012); Giuseppe Giovanni Battaglia, un poeta corsaro, in Aa. Vv. Laicità e religiosità nell’opera di G.G. Battaglia (2018); Eredità dissipate. Gramsci Pasolini Sciascia, Diogene editore Bologna 2022.
____________________________________________
TENTATIVI DI REVISIONE DELLA MEMORIA DEL CARDINALE RUFFINI
Il cardinale Ernesto Ruffini e la mafia siciliana: una
questione aperta
Pubblicato il 1 maggio 2024 da Comitato di Redazione
di Augusto
Cavadi
Il
cardinale Ernesto Ruffini, arcivescovo di Palermo dal 1945 al 1967 (anno della
morte), è stato certamente una delle figure più chiacchierate del mondo
cattolico nel XX secolo. Un presbitero palermitano, don Francesco Conigliaro,
ne ha voluto restituire un ritratto per quanto possibile oggettivo, nel
volume Sed contra. Ruffini dice che la mafia esiste. Pagine sul
Cardinale Ernesto Ruffini Arcivescovo di Palermo (Carlo Saladino
Editore, Palermo 2020). In questo corposo saggio l’autore, pur senza tacerne
alcuni limiti, si impegna a difendere la memoria del vescovo da giudizi che
ritiene ingiustamente detrattori, dando riprova di due caratteristiche della
sua personalità: una senz’altro positiva, l’anticonformismo intellettuale;
l’altra, meno apprezzabile, la vis polemica.
Meriti
del cardinale
Di
Ruffini, Conigliaro evoca la fede autentica e sincera; il forte pathos apostolico;
la profeticamente illuminata “carità sociale” che lo ha indotto a una serie
considerevole di iniziative volte a sradicare le cause profonde della povertà
diffusa in diocesi soprattutto nei due decenni immediatamente successivi al
disastro della Seconda guerra mondiale, in cui l’Italia era stata criminalmente
coinvolta da Mussolini e dai suoi complici.
Del
fedele segretario Longhi, l’autore di questa monografia riporta una
testimonianza su qualche aspetto privato del cardinale la cui immagine pubblica
era, volutamente, circonfusa del fasto a suo parere dovuto a un “principe”
della Chiesa cattolica:
«Pochi, forse, conobbero la frugalità della sua
mensa quotidiana (“Lo stomaco – affermava – è un monello da educare”) e la
povertà di conforti della cameretta, la piccola alcova dello studio personale.
Soltanto dopo il menzionato incidente [nel 1960, in seguito ad una caduta, si
era spezzato il femore], che lo costrinse a letto, accettò una camera
accogliente con servizi normali. Non volle mai, per sé, né riscaldamento né
condizionatore d’aria».
Più
rilevanti, ovviamente, le opere sociali progettate e realizzate (in epoca –
ricordiamo – in cui non esisteva il Servizio sanitario nazionale per ogni
cittadino e l’obbligo scolastico sino ai 14 anni era ampiamente disatteso):
«a) Servizi di pronto intervento (unificati
nelle opere arcivescovili di assistenza): aiuto economico, oratori
arcivescovili, colonie estive, soccorso invernale, corsi scolastici per adulti,
assistenza lavoratori;
b) Contributo all’avvio e allo sviluppo
del servizio sociale: servizio sociale aziendale, servizio sociale
scolastico, servizio sociale rurale, servizio sociale in enti pubblici;
c) Opere e servizio socio-sanitari,
educativo-promozionali: poliambulatorio, centri di servizio sociale,
Istituto “Angelo Custode”, Villaggio Cardinale Ruffini, Scuola Superiore di
Servizio Sociale “Santa Silvia”, scuole materne, Villaggio dell’ospitalità,
pensionati femminili, Casa della Gioia, Centro di formazione professionale “S.
Giuseppe”, Pensionato “S. Saverio”, Casa della serenità, Casa della
misericordia;
d) Collaborazione con enti in altre città
mediante il servizio sociale missionario: scuole di servizio sociale,
servizi sperimentali in alcune diocesi».
La
conclusione di Conigliaro è davvero lusinghiera (soprattutto se si tiene
presente il confronto implicito tra Ruffini e il suo celebratissimo successore
Salvatore Pappalardo): «A mio sommesso parere, è stato il più grande
arcivescovo palermitano del secolo XX. Certamente il più santo, il più onesto,
il più intelligente ed il più colto».
Forse
posso qui riferire, a conforto di Conigliaro, un piccolo aneddoto
autobiografico che conferma l’umanità caratteriale del presule. Quando avevo
cinque anni i miei genitori mi accompagnarono in chiesa per una celebrazione
con l’arcivescovo e, al momento della distribuzione dell’eucarestia, mi
incolonnai in fila per ricevere la mia particola. Una suora se ne accorse e,
alla fine della messa, chiamò i miei genitori e li trascinò allarmata in
sacrestia per informare il presule del sacrilegio: non avevo ancora completato
il corso di catechismo né mi ero mai confessato. Ruffini rispose con un sorriso
rassicurante: «E voi pensate che oggi abbia dato la comunione a qualcuno più
innocente di questo bambino?»
Limiti
del cardinale
Qua
e là l’autore richiama anche aspetti problematici del suo amato personaggio: ad
esempio una severità sproporzionata verso i seminaristi, come quando sospese
l’ordinazione diaconale dello stesso Conigliaro minacciandolo di allontanamento
definitivo perché, insieme ad altri, si era permesso di andare, «senza
autorizzazione, a vedere, il film La Bibbia di John Huston».
(Un altro prete, mio docente di religione al liceo, mi raccontò di essere
stato, ancora seminarista, convocato da Ruffini per essere duramente ammonito:
il giovane non si era inginocchiato per strada al passaggio dell’automobile
cardinalizia preceduta come di solito da due motociclisti delle Forze
dell’ordine). Oppure la sua “ingenuità” che lo induceva
«a valutare positivamente ciò che per principio
non poteva non essere positivo. Ecco perché per lui era impensabile che uomini
di Chiesa, chiamati a vivere come discepoli del Signore, potessero essere
compromessi con la mafia, che si macchiava di crimini efferati, e non dubitava
mai degli uomini delle istituzioni, dei quali dimostrava sempre di avere un
alto concetto»,
tranne
quando questi uomini – «e qui ingenuità si aggiungeva ad ingenuità» – si dimostravano
poco combattivi contro «le forze politiche di sinistra»: il suo «anticomunismo
deciso» (ivi) impedì qualsiasi rinnovamento nella composizione delle giunte di
governo regionale, contribuendo forse involontariamente al degrado etico della
Democrazia Cristiana, troppo sicura di ottenere comunque la maggioranza dei
voti ad ogni elezione (Conigliaro avrebbe potuto aggiungere che il cardinale in
campagna elettorale invitava per iscritto preti, suore e fedeli a votare per il
“partito cattolico” ed anzi chiamò dalla Lombardia il figlio di un fratello,
Attilio Ruffini, che costruì proprio a Palermo una rapida carriera politica
sino ai vertici del governo nazionale, conclusasi in maniera brusca e assai
poco limpida). In una nota a piè di pagina Conigliaro afferma che
«non si riesce a capire la ragione per cui lo
stesso cardinale, che per il seminario diocesano s’impegnò al massimo delle
possibilità e dei mezzi di cui disponeva sia per l’edilizia che per la qualità
della vita dei seminaristi, nel settore degli studi consentì il porsi di un
processo continuo di degradazione, soprattutto a motivo della graduale
dequalificazione dei docenti (ci furono professori improvvisati anche nel corso
teologico) e della totale incuria della biblioteca (quella esistente, a motivo
di un irragionevole smembramento, fu resa inutilizzabile e non fu aggiornata)».
Qui
è Conigliaro stesso a peccare d’ingenuità come il suo amato arcivescovo:
Ruffini era un testardo conservatore in teologia (mons. Emanuele Parrino ci
raccontò di essere stato chiamato in curia dove il presule, appena tornato da
Roma dopo l’approvazione della Costituzione conciliare Dei Verbum,
tra le lacrime, gli confidava l’angoscia per la protestantizzazione della
Chiesa cattolica sul tema del rapporto tra Bibbia e Tradizione: «I miei
confratelli vescovi hanno distrutto la Chiesa !»); sapeva benissimo quali
sommovimenti erano in atto nella Chiesa ad opera dei biblisti e dei
“sistematici” più esperti (egli stesso era stato docente di Scienze bibliche a
Roma); dunque non poteva fare spazio ai novatores né in carne
ed ossa né attraverso le loro pubblicazioni. Si capisce benissimo perché
consentisse d’insegnare solo a chi era disposto pappagallescamente a
trasmettere la “dogmatica” ottocentesca (talora per mancanza di coraggio,
talora per ambizione di carriera, talaltra proprio perché in buona fede
convinto che l’impalcatura concettuale edificata dal Medioevo al XX secolo
fosse ben fondata sulle Scritture e sulla ragione naturale) e perché vietasse
di acquistare libri che potessero contribuire a quell’ “aggiornamento” che
Ruffini avrebbe pervicacemente contrastato nel corso del Concilio Ecumenico
Vaticano II (1962-965).
In
questa logica censoria rientrava il divieto per gli aspiranti al sacerdozio di
acquisire anche titoli accademici rilasciati da università statali, divieto di
cui lo stesso Conigliaro dichiara di essere stato vittima: il prete ruffiniano
non doveva essere troppo informato di ciò che accadeva nella cultura “laica” né
tanto meno possedere una laurea ‘civile’ che, in caso di “pentimento”, gli
consentisse un lavoro fuori dalle strutture ecclesiastiche. Più in generale, il
cardinale interpretava in maniera paternalistica il suo ruolo di “pastore” sul
presupposto che i fedeli fossero troppo ignoranti e immaturi per regolarsi da
sé: anche se Conigliaro non ha modo di ricordarlo, la diocesi di Palermo era
forse l’unica al mondo in cui si incorresse nella scomunica latae
sententiae (per intenderci: automatica, senza bisogno che qualche
autorità gerarchica la comminasse esplicitamente ad personam) se si
entrava in un tempio valdese o anglicano, anche solo per ragioni turistiche e
senza assistere a nessun culto “ereticale”.
Né
Ruffini mostrava particolare fiducia nei suoi più stretti collaboratori.
Celebre il breve discorso in cui egli diede l’annunzio della nomina del suo
vescovo ausiliario, mons. Filippo Aglialoro (discorso a braccio che mi è stato
riferito da uno dei preti presenti):
«Oggi L’Osservatore Romano dà
notizia della nomina, da parte del Santo Padre, di monsignor Aglialoro a
vescovo ausiliario di Palermo. Di lui tutto si può dire tranne che non sia
obbediente. Si potrebbe obiettare che le sue condizioni di salute non siano
eccellenti, ma non dovrà lavorare molto: l’abbiamo scelto a ornamento
dell’arcidiocesi».
Conigliaro
riporta una serie di citazioni che attesterebbero una sorta di conversione
finale di Ruffini alle conclusioni del Concilio ecumenico Vaticano II: se tale
conversione è davvero avvenuta, non posso che rallegrarmi per la buonanima del
presule. Ma senza trascurare che sarebbe avvenuta soltanto a circa un anno
dalla sua morte improvvisa per infarto subito dopo aver deposto la scheda in
occasione di elezioni amministrative. Se è vero l’aneddoto che circolò allora –
una battuta confidenziale di Paolo VI rattristato per la resistenza
anticonciliare di Ruffini e del suo amico Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova:
«Sapete se ci saranno anche in Liguria delle elezioni amministrative
nell’immediato futuro?» – la notizia della tardiva conversione del “tradizionalista”
Ruffini non dovette arrivare tempestivamente in Vaticano.
Ruffini
ha negato l’esistenza della mafia?
Il
cuore del volume, come annunziato già nel sottotitolo (Ruffini dice che la
mafia esiste), è costituito dalla decostruzione di due asserzioni
comunemente e falsamente attribuite al cardinale lombardo: che «la mafia non
esiste» e che essa è piuttosto «invenzione del socialcomunisti». Questa accusa
si basa su un’esegesi tendenziosa di una lettera di Ruffini, in risposta a
monsignor Angelo Dell’Acqua che, dopo la strage di Ciaculli (1963), a nome del
papa Paolo VI, aveva lodato un’iniziativa del pastore valdese Pier Valdo
Panascia e sollecitato l’arcivescovo di Palermo a promuovere «un’azione
positiva e sistematica […] per dissociare la mentalità della cosiddetta ‘mafia’
da quella religiosa». In questa risposta alla Segreteria di Stato vaticana,
Ruffini aveva letteralmente scritto:
«Mi sorprende alquanto che si possa supporre che
la mentalità della cosiddetta mafia sia associata a quella religiosa. È una
supposizione calunniosa messa in giro, specialmente fuori dall’isola di
Sicilia, dai socialcomunisti, i quali accusano la Democrazia Cristiana di
essere appoggiata dalla mafia».
Conigliaro
contesta la “ermeneutica antiruffiniana” di queste righe che opera «un duplice
massacro: quello del testo della lettera e quello della persona di Ruffini».
Egli cita in proposito una lunga serie di intellettuali che, come una valanga,
si sarebbero sommati avviluppandosi l’un dopo l’altro in questa accusa di
“negazionismo”: padre Ennio Pintacuda, Antonio Roccuzzo, Roberto Scarpinato,
Enzo Biagi, Luciano Mirone, padre Nino Fasullo, don Rosario Giué, Saverio
Lodato, Nino Alongi, mons. Domenico Mogavero. Don Francesco Michele Stabile è
l’interlocutore principale del libro di Conigliaro, dalla prima all’ultima
pagina: sarebbe “caposcuola” dell’ermeneutica “antiruffiniana” , ma non
responsabile delle esasperazioni interpretative che gli studiosi successivi
avrebbero tratto dalla sua ricerca storiografica.
A
parere di Conigliaro – e mi pare che qui difficilmente gli si possa dar torto –
nel passaggio appena citato della lettera a Dall’Acqua, Ruffini non ha negato
l’esistenza della mafia, ma l’esistenza di un collegamento fra mafia e
mentalità religiosa; inoltre ha accusato i socialcomunisti di aver inventato
non la mafia, ma il collegamento della mafia con il partito cattolico, la
Democrazia Cristiana.
Ciò
precisato, dal punto di vista per così dire filologico-esegetico, Conigliaro
ammette onestamente che comunque le opinioni del compianto arcivescovo non
siano condivisibili. Infatti egli, ragionando in maniera astratta, era convinto
che «tra autentica mentalità religioso-cristiana e mentalità mafiosa non è
pensabile alcuna associazione» e, «applicando la propria ingenua logica
deduttiva, escludeva che tra cristiani (nella mentalità, nella Chiesa e nella
politica) e mafia ci potessero essere complicità». Su questo tema «l’analisi
storica ha dato torto a Ruffini»: «aveva torto, ma tutto ciò che a questo
proposito gli si può rimproverare è, oltre l’ingenuità, la sottovalutazione
della mafia, delle sue attitudini e delle sue possibilità».
Veramente
a Ruffini si potrebbe rimproverare un’altra cecità (ma questa comune a molti
papi, vescovi e teologi, Conigliaro incluso): che se il nucleo originario dell’evangelo
cristiano è davvero incompatibile con una mentalità mafiosa, non
altrettanto incompatibile con questa lo è il complesso dogmatico, etico,
simbolico, giuridico, linguistico costituito dal cattolicesimo
mediterraneo (intriso di antropomorfismo teologico, patriarcato,
gerontocrazia, familismo, misoginia, sessuofobia e molto altro) [1].
Ruffini
non ha negato, insomma, l’esistenza della mafia. E mi pare prezioso il
riferimento ad una intervista, che non conoscevo, in cui lo stesso Ruffini –
quattro anni prima allo scambio di lettere con Roma – dichiara a F. Rosso
de La Stampa di Torino:
«Qui abbiamo problemi enormi da risolvere, pensi
a cosa è la mafia, alla sua rete di delitti. Già i mezzi per combatterla sono insufficienti
e come se non bastasse arriva una nuova amnistia. Faccia il calcolo di quante
amnistie sono state concesse dalla fine della guerra, una ogni due anni».
Ha
parlato della mafia, ma in termini riduttivi, come mero fenomeno delinquenziale
di ordine pubblico. È vero che in questo condivideva l’opinio communis attestata
perfino dai magistrati siciliani nei loro interventi pubblici, ma Conigliaro
deve ammettere che il Parlamento aveva varato una Commissione antimafia (di cui
Ruffini mette in evidenza, per criticarla, il «carattere marcatamente
politico») e che il quotidiano L’Ora del tempo divulgava
un’idea più ampia di mafia come soggetto non solo militare, ma anche economico,
politico e culturale. Potremmo aggiungere che questa visione più articolata del
sistema mafioso era stata offerta a chi avesse avuto sincera volontà di capire
già dal liberale Franchetti nel 1876 nella sua relazione su Le
condizioni sociali e amministrative della Sicilia e, in tempi più
vicini a Ruffini, da intellettuali come Mario Mineo, Michele Pantaleone,
Leonardo Sciascia ed altri (tra cui Danilo Dolci su cui torneremo fra breve).
Di
queste voci ‘profetiche’ non mi pare tengano conto i commentatori di ogni
orientamento, i quali convergono univocamente nella considerazione (attenuante)
che «l’approccio ruffiniano a quell’epoca era quello stesso dei procuratori
della repubblica di Palermo e, si può aggiungere, dei prefetti, dei questori e
dei generali dell’arma dei carabinieri». Ruffini, condizionato
dalla presunzione di essere esponente apicale di una Chiesa docente in nome e
per conto dello Spirito Santo, non ebbe nessun desiderio di imparare da fonti
“laiche” competenti come, in quegli stessi anni, molti dei suoi confratelli
riuniti in concilio al Vaticano raccomandano ai fedeli per decifrare le
problematiche storico-sociali. Secondo Conigliaro, sarebbe persino eccessivo
affermare che Ruffini si sia preoccupato di tenersi lontano dalle «tesi proprie
della sinistra»:
«Tenendo conto del tipo che era Ruffini e
dell’idea che aveva di quelli che egli chiamava socialcomunisti, escludo che
ciò possa essere accaduto consapevolmente: credo di poter sostenere che non ha
neppure preso in considerazione quelle tesi».
Si
potrebbe notare che Ruffini non ha avuto orecchie neppure per le rare voci del
mondo cattolico che mostravano di intuire le reali dimensioni del sistema di
dominio mafioso, come il vescovo di Agrigento G.B. Peruzzo e don Luigi Sturzo
(di cui neppure Conigliaro ricorda il testo teatrale Mafia).
L’autore di
questo volume ricorre a una Lettera pastorale di Ruffini, di
nove mesi successiva all’infelice risposta a monsignor Dall’Acqua,
intitolata Il vero volto della Sicilia (1964), per rafforzare
la sua tesi: Ruffini non solo ha parlato della mafia, ma ne ha parlato in
termini storico-sociologicamente aggiornati. Infatti, dopo aver redatto le
famigerate frasi «In questi ultimi tempi si direbbe che è stata
organizzata una grave congiura per disonorare la Sicilia: e tre sono i fattori
che maggiormente vi hanno contribuito: la mafia, il Gattopardo, Danilo Dolci»
frasi
nelle quali, incredibilmente, la malattia (la mafia) viene equiparata per
pericolosità al medico (Danilo Dolci) – recependo le analisi di G.G.
Loschiavo in 100 anni di mafia (Roma 1962), egli scrive:
«Qui è necessario richiamare le condizioni dell’agricoltura nella Sicilia Centrale e Occidentale di quei tempi [la seconda metà dell’Ottocento]. Venuta meno la difesa che proveniva dall’organizzazione feudale e infiacchitosi il potere politico, i latifondi ebbero bisogno di assoldare squadre di picciotti e di poveri agricoltori per assicurare il possesso delle loro estese proprietà. Si venne così a costituire uno Stato nello Stato, e il passo alla criminalità, per istinto di sopraffazione e di prevalenza, fu molto breve. Tale può ritenersi, in sostanza, l’origine della mafia contemporanea».
Dunque
sino a quando i feudatari, in barba a tutti i provvedimenti costituzionali che
dal 1812 in poi avevano abolito il feudalesimo, si fanno un esercito privato
per impedire ai contadini di diventare proprietari delle terre che coltivano da
secoli in condizioni peggiori della schiavitù, per Sua Eminenza (e per il suo
generoso apologeta Conigliaro) saremmo nella legalità. Il “passo alla
criminalità” sarebbe stato compiuto quando questo esercito privato decide di
emanciparsi dalla sudditanza nei confronti dell’aristocrazia feudale e, «per
istinto di sopraffazione e di prevalenza» (!), di esercitare in proprio la
violenza. Della tragedia dei Fasci siciliani nell’ultimo decennio del XIX
secolo non c’è neppure una labile traccia. Direi per fortuna, perché temo che
nella mentalità spaventosamente medievale di Ruffini la repressione dei
contadini in rivolta, per il diritto elementare di non morire di fame e di non
vedersi sottrarre totalmente il frutto del proprio sudore, operata
congiuntamente dall’esercito e dai mafiosi, sarebbe stata esaltata come un
ritorno dalla “criminalità” alla legalità del possesso nobiliare dei latifondi.
Neanche una linea neppure sulle numerose stragi politico-mafiose del Secondo
dopoguerra di cui Portella della Ginestra (1947) è solo la punta più eclatante.
Molto opportunamente don Stabile nota che il tentativo di Ruffini di
incrementare l’impegno civile dei cattolici
«rimase circoscritto alla lotta anticomunista e a
una solidarietà che rimaneva sul piano del servizio sociale e assistenziale e
non arrivava alla rivendicazione sociale della terra (come invece avrebbe
voluto mons. Peruzzo, vescovo di Agrigento), perché la riforma della proprietà
fondiaria avrebbe potuto spezzare il fronte anticomunista con le destre».
In
(provvisoria) conclusione
Per
dirimere la questione se Ruffini abbia negato o meno la mafia bisognerebbe
accordarsi, preliminarmente, su una questione lessicale. Se per mafia
intendiamo, come intende Ruffini, una delle tante forme di criminalità operanti
da sempre (e direi per sempre) in tutte le aree del pianeta, Ruffini non ne ha
negato l’esistenza. Anzi, l’ha stigmatizzata ripetutamente. Se, invece, con lo
stesso termine indichiamo un soggetto militare, economico, politico e culturale
costituito da “una sparuta minoranza” di siciliani che contano sulla complicità
di una molto più consistente minoranza (Tommaso Buscetta sosteneva che i circa
5.000 “uomini d’onore” delle “famiglie” mafiose potessero contare su circa un
milione di siciliani di ogni strato sociale, dunque su un quinto della
popolazione complessiva dell’Isola), Ruffini ne ha negato l’esistenza. È
davvero stupefacente sostenere ai nostri giorni, come fa don Conigliaro, che
«Ruffini ha parlato della mafia e ne ha colto perfettamente la natura» e che,
«se si vuole continuare a parlare di sottovalutazione della mafia anche a
proposito della lettera pastorale di quest’anno [1964], è necessario precisare
che essa rimane a livello pastorale-pratico, ma non più a livello
teorico».
Se
Ruffini abbia negato il vero volto della mafia per dolo o in buona fede è
un’altra questione che va distinta dalla prima (e che, pertinendo alla sfera
della coscienza individuale e delle intenzioni soggettive, è forse impossibile
dirimere). E se in questa negazione (o intenzionale o inconsapevole) sia stato
preceduto, affiancato e seguito da una pletora di studiosi, di magistrati, di
politici, di insegnanti, di preti è un’altra questione ancora: se errore ci fu,
le attenuanti non lo azzerano.
La
necessità epistemica di distinguere queste tre questioni è quanto ho ricavato,
alla fin dei conti, dalla lettura del libro di Conigliaro. E potrebbe essere un
istruttivo punto di (ri)partenza per quanti in futuro vorranno occuparsi della
vicenda.
Dialoghi
Mediterranei, n.
67, maggio 2024
Note
[1] Cfr. A.
Cavadi, Il Dio dei mafiosi, San Paolo, Milano 2009 e il
saggio Una chiave di lettura complessiva contenuto nel volume
da me curato Il Vangelo e la lupara. Documenti e studi su Chiese e
mafie, Di Girolamo, Trapani 2019: 9-58. Per entrambi gli scritti sono
debitore agli spunti ‘pionieristici’ di don Cosimo Scordato nel suo Abbozzo di una riflessione teologica ‘cattolica’’,
originariamente ospitato con il titolo Chiesa e mafia sulla
rivista “Il Regno-attualità” (1992: 37), poi ripubblicato nella mia
raccolta Il Vangelo e la lupara. Materiali su Chiese e mafia,
vol. I (Storia. Teologia. Pastorale), Edizioni Dehoniane, Bologna 1994:
157-162.
__________________________________________________________________________________
Augusto Cavadi, già docente presso vari Licei siciliani,
co-dirige insieme alla moglie Adriana Saieva la “Casa dell’equità e della
bellezza” di Palermo. Collabora stabilmente con il sito
http://www.zerozeronews.it/. I suoi scritti affrontano temi relativi alla
filosofia, alla pedagogia, alla politica (con particolare attenzione al
fenomeno mafioso), nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici e
spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei
mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza della politica.
Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo,
2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo,
2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima
spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); La mafia desnuda –
L’esperienza della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone”
(Di Girolamo, 2017); Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia
e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018), Dio visto da Sud. La
Sicilia crocevia di religioni e agnosticismi (SCe, 2020); O
religione o ateismo? La spiritualità “laica” come fondamento comune (Algra
2021).


.jpg)

.jpg)




.jpg)





