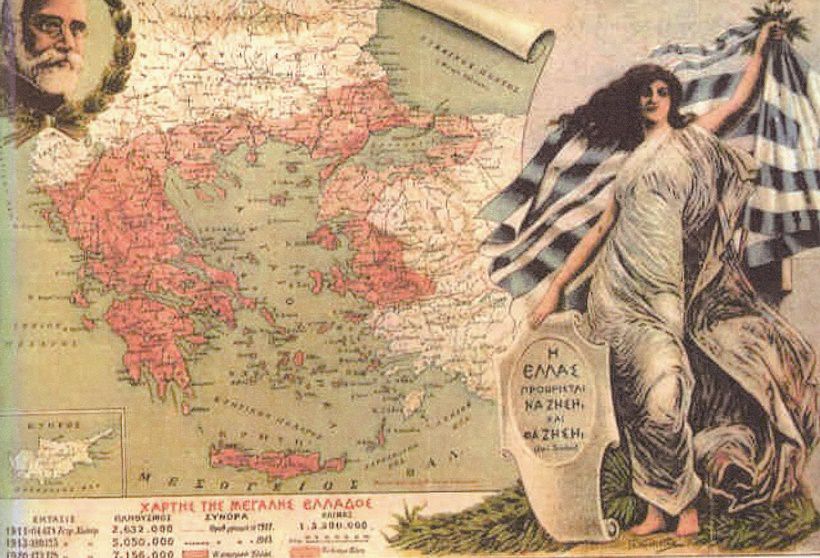Con Montaigne nasce l'occidente moderno
di Alfonso
Berardinelli
E’ sempre esistito l’individuo?
A prima vista e proiettando nel passato noi
stessi, sembrerebbe di sì. In realtà ogni cultura e epoca ha creato
la sua idea dell’io e del suo rapporto con la società. La stessa
idea di società è nata in occidente solo con la modernità
sette-ottocentesca, quando individui e popolo si sono dissociati
dallo stato assoluto e ne hanno contestato la legittimità. E’ solo
allora che comincia a profilarsi una nuova disciplina, la sociologia,
termine inventato da Auguste Comte negli anni che precedettero le
rivoluzioni del 1848, anno di pubblicazione del Manifesto di Marx e
Engels.
Quanto all’individuo isolato e dissociato
dall’insieme sociale, sembra nascere con alcuni celebri personaggi
letterari, veri e propri “miti dell’individualismo moderno”,
come ha spiegato nel suo libro omonimo il critico Ian Watt. Questi
personaggi e miti sarebbero Faust, don Chisciotte, don Giovanni e
Robinson Crusoe, ai quali andrebbero aggiunti almeno l’Amleto
shakespeariano e Alceste, il “misantropo” di Molière, al quale
gli “equilibristi del vivere sociale” ripugnano. Ma in queste
ultime incarnazioni originarie dell’individuo isolato in sé, lo
sfondo antagonistico non è la società in senso generale, è la vita
di corte. In filosofia si dice che l’“io penso dunque sono” di
Cartesio segna la nascita dell’autonomia individuale: basta pensare
per esistere, il resto non conta. Una cosa, questa, che ai filosofi
piace molto, perché è molto radicale e molto astratta.
Ma chi è più precisamente, empiricamente,
questo “io”? L’individuo è tale perché presenta delle
singolarità che non vanno taciute ma espresse e descritte. Mezzo
secolo prima di Cartesio questa impresa era stata compiuta da Michel
De Montaigne con la sua unica opera, i Saggi, usciti per la prima
volta nel 1580. E Montaigne, vero inventore dell’individuo
occidentale moderno, si presentava così: “Questo, caro lettore, è
un libro sincero. Ti avverte fin dall’inizio che con esso non mi
sono proposto alcun fine, se non privato e domestico. Non ho tenuto
in considerazione né il tuo vantaggio né la mia gloria. Le mie
forze non bastano a tali propositi. L’ho dedicato all’utilità
privata dei miei parenti e amici (…) Se lo avessi scritto per
procurarmi il favore della gente, mi sarei migliorato e presentato in
atteggiamenti più studiati. Voglio che mi si veda qui nel mio
semplice modo di essere, naturale e consueto, senza pose né
artifici: perché è me stesso che ritraggo (…) sono io stesso la
materia del mio libro: non c’è ragione perché tu spenda il tuo
tempo con un argomento così frivolo e vano”.
Molta naturalezza, a cui lo stile di Montaigne
resterà fedele. Ma l’artificio, come si capisce dalla frase
finale, non è del tutto escluso. Non ci si presenta al lettore
incoraggiandolo a non leggere. Questa esibizione di umiltà è
ovviamente un’astuzia retorica e una provocazione preliminare. Come
dire: gli individui reali, per come sono e basta, non hanno finora
meritato di essere il solo tema di un’opera letteraria o
filosofica. Quello che ho fatto sfida le convenzioni culturali, dà
importanza a ciò che non importa e scopre un mondo, prossimo e
accessibile, ma in precedenza ignorato.
La rivoluzione individualista di Montaigne
comincia da qui.
Senza il suo autoritratto non ci sarebbero stati
i monologhi autodenigratori di Amleto, il suo annoiarsi a morte di
fronte al dovere politico della vendetta. Rousseau non avrebbe
scritto, due secoli dopo, le sue Confessioni e le tecniche
introspettive del romanzo moderno sarebbero state inconcepibili.
Chiuso nella torre del suo castello, di fronte alla sua biblioteca di
classici, con le pareti tappezzate di sentenze e di aforismi, mentre
fuori infuriavano le guerre di religione fra cattolici e protestanti,
Montaigne studia se stesso. Ma più si insegue e più si convince che
l’io è mobile, l’identità è multipla, la conoscenza oscilla
fra certezze solo momentanee.
Nato il 28 febbraio 1533 nel segno dei Pesci da
padre cattolico e madre di origine ebraica, in un castello nelle
vicinanze di Bordeaux, Michel Eyquem De Montaigne ricevette dal suo
amato e tollerante padre un’educazione di stile italiano, senza
rigidezze e severità. Il suo precettore tedesco, Horstanus, non
conosceva il francese e insegnò al bambino a parlare il latino. Dopo
gli anni di collegio in Guyenne, a poco più di vent’anni,
Montaigne, che aveva studiato diritto, ebbe la nomina di consigliere
nell’amministrazione pubblica di Périgueux, poi entrò nel
parlamento di Bordeaux e conobbe quello che sarà il grande amico
della sua vita, quell’Etienne de la Boétie autore del famoso
scritto sulla Servitù volontaria, di cui curò, dopo la sua morte,
l’edizione delle opere.
La perdita precoce di questo amico fu uno degli
eventi più dolorosi e decisivi nella vita di Montaigne. Più tardi,
sollecitato da Enrico III, fu sindaco di Bordeaux quando aveva già
pubblicato la prima edizione dei suoi saggi in due libri, ai quali
nel 1588 se ne aggiunse un terzo. Già da quando aveva trentotto anni
aveva deciso di ritirarsi a vita privata per riflettere, leggere e
scrivere. Grande lettore di classici soprattutto latini
(continuamente citati e ruminati sono Catullo e Virgilio, Orazio,
Ovidio, i satirici Marziale e Giovenale, i filosofi morali Cicerone e
Seneca), Montaigne passa dal commento all’autoritratto. Come
lettore, più che un erudito è un individuo che scopre, misura e
saggia se stesso. La pratica della solitudine riflessiva non ha in
lui niente di ascetico, induce piuttosto all’onesta descrizione
della propria vita quotidiana e alla valorizzazione del puro e
semplice vivere. Impresa d’altra parte niente affatto tranquilla e
lineare: “Quando recentemente mi sono ritirato a casa mia, deciso a
occuparmi il più possibile di nient’altro che di trascorrere in
pace e appartato quel tanto di vita che mi resta, mi sembrava di non
fare al mio spirito favore più grande che lasciarlo nell’ozio più
completo a conversare con se stesso e soffermarsi e riposarsi in se
medesimo (…) Ma trovo che invece, come un cavallo che rompe il
freno, il mio spirito mi procura cento volte più preoccupazioni da
solo di quante se ne facesse per gli altri. E genera in me tante
chimere e mostri fantastici uno sull’altro, senza ordine e senza
motivo, che per contemplarne a mio agio la balordaggine e la
stravaganza, ho cominciato a registrarli nella speranza che col tempo
mi vergogni di me stesso” (Libro I, capitolo
 .
.
E’ la mossa tipica di Montaigne: abbassare
invece che nobilitare. L’eroe autobiografico è in realtà un
moderno antieroe. E questa pratica dispone di un metodo infallibile:
la considerazione della stretta convivenza di corpo e anima. Come ha
osservato Erich Auerbach, uno dei suoi più acuti e simpatetici
studiosi, l’avversione di Montaigne va “a tutti i sistemi
pedanteschi di filosofia morale, ai quali rimprovera l’astrattezza
dei metodi che travestono la realtà della vita con la gonfiezza
della loro terminologia, cose che si possono ricondurre al fatto che,
in parte nella teoria e in parte nell’insegnamento pratico, vengono
separati l’anima e il corpo, impedendo a quest’ultimo di dire la
sua”.
Il corpo ha le sue pigrizie e le sue lentezze.
Anche la mente ne è condizionata e i suoi movimenti possono essere
descritti e messi in scena come movimenti corporei. Parlando per
esempio dell’educazione (Libro I, capitolo 26), Montaigne comincia
con l’esibire la propria renitenza a sfinirsi sui libri: “Insomma,
io so che esiste la medicina, la giurisprudenza, la matematica divisa
in quattro parti. E so all’ingrosso di che cosa trattano (…) Ma
andare più a fondo e logorarmi sui libri studiando Aristotele,
sovrano del sapere, o intestardirmi su qualche scienza, questo non
l’ho mai fatto; e non c’è arte di cui sarei capace di delineare
i principi (…) I miei pensieri e il mio giudizio procedono a
tentoni, esitano, vacillano e inciampano; e quando sono andato più
avanti che ho potuto, non mi sono sentito per niente soddisfatto; ho
visto altre terre davanti a me, ma confusamente, e come in una nebbia
che non riuscivo a penetrare”.
Esistere non è pensare, ma cercare di farlo. In
questo senso e con l’invenzione di questo stile non enfatico, non
astratto e antieroico, si potrebbe dire che Montaigne è il primo
filosofo “esistenzialista”, il primo indagatore dell’esistenza
come singolarità reale. Anche il mondo è visto da lui attraverso la
lente dell’autoanalisi. Quanto alla società, alla politica, alle
guerre di religione e alle ambizioni di potere, il suo è uno
“sguardo da fuori”, lo sguardo di un uomo che si allontana, si
autoesclude, si ausculta per capire di quale insieme molecolare di
impulsi, paure, desideri, abitudini e inerzie è fatta la vita di
ogni giorno ai suoi livelli elementari. Il moralismo di Montaigne è
materialistico e scettico. Descrittivo, non normativo. La realtà è
quanto l’io è in grado di vedere e di capire, senza illudersi di
conoscere davvero ciò di cui non può fare esperienza: “Vorrei che
ognuno scrivesse quello che sa, e quanto ne sa (…) Poiché uno può
anche avere qualche particolare cognizione o esperienza della natura
di un corso d’acqua o di una sorgente e per il resto sapere solo
cose che sanno tutti. Eppure, pur di mettere in circolazione questa
sua minuscola conoscenza si mette a scrivere su tutta la fisica. E’
da questo vizio che nascono tanti grandi inconvenienti” (Libro I,
capitolo 31).
Prendendo sul serio e coerentemente il socratico
“conosci te stesso”, Montaigne si trova di fronte un’entità
polimorfa e porta l’umanistica esaltazione dell’uomo dal cielo
delle idee generali alla terra dei fenomeni minimi personalmente
osservabili: “Negli uomini io credo più difficilmente alla loro
costanza che a ogni altra cosa, e a niente credo più facilmente che
alla loro incostanza (…) Di solito non facciamo che andare dietro
alle inclinazioni del nostro desiderio, a sinistra, a destra, in su e
in giù, secondo che il vento delle occasioni ci trascina. Pensiamo a
quello che vogliamo solo nel momento in cui lo vogliamo e cambiamo
come quell’animale che prende il colore del luogo in cui lo si
mette” (Libro II, capitolo 1).
Con questo siamo ben lontani, al di là, o al di
qua, del grandioso umanesimo antropocentrico italiano, fondato
sull’idea di rispecchiamento fra quel microcosmo che è l’uomo e
il macrocosmo universale. Montaigne sa bene di non avere in sé tutto
l’universo. La sola idea lo spaventerebbe. Cita spesso Platone, ma
il suo filosofo è piuttosto Epicuro. I piaceri e i dubbi ragionevoli
sono il sale della sua riflessione. Niente è stabile e certo. Ogni
punto di vista ha una sua legittimità e tutto ciò che è piacevole
è preferibile a ciò che è sgradevole e scomodo. La stessa
grandezza degli uomini famosi la considera “incomoda” e sospetta,
perché altera la naturalezza e la misura.
Anche lo stile saggistico di Montaigne,
prototipo della prosa letteraria di pensiero che trionfò nel
Settecento illuministico (con Addison, Rousseau, Diderot,
Lichtenberg, Chamfort, Pietro Verri), risponde agli stessi criteri di
sinuosa duttilità. Esprime l’etica dello scrittore, il suo ideale
di vita, i suoi propositi, i ritmi della sua vita mentale: “Sentii
di aver raggiunto il vero stile quando riuscii a parlare alla carta
come faccio con la prima persona che incontro”. Questo culto della
semplicità e della naturalezza ha anch’esso una radice epicurea:
non è un sapere per le élite, ma per chiunque.
Montaigne condanna l’oscurità di linguaggio,
la paura immaginaria e la tristezza, da cui dice di essere immune.
Nel saggio sulla “vanità delle parole” (Libro I, capitolo 51)
osserva che il retore è come un calzolaio che faccia scarpe più
grandi di quanto sono i piedi, e fa sembrare grandi cose che non lo
sono. Vano è tutto ciò che supera le proprie reali possibilità.
Vivere ritirato e indulgere a una certa pigrizia non lo giudica
spregevole. E tuttavia ritiene che “la più onorevole occupazione
sia giovare alla gente e essere utile a molti” (Libro III, capitolo
9).
Dunque realismo, autocoscienza, moderazione,
accettazione dei propri limiti e delle opinioni diverse dalle
proprie. Fanatismi e enfasi gli ripugnavano. Va riconosciuto che
leggere Montaigne è più calmante che eccitante, se gli si sente
dire che ciò che è grandioso corre maggiori rischi, mentre “tutto
ciò che vacilla non cade”.
Se si confronta questo umanesimo del secondo
Cinquecento con quello italiano che va da Marsilio Ficino e Giovanni
Pico Della Mirandola, fino alle statue equestri di Donatello e
Verrocchio, fino al Mosè e al Davide di Michelangelo, si nota un
deciso rovesciamento e abbassamento di tono, di propositi e di
ideali. L’interesse di Montaigne per gli altri è costante, ma egli
nutre una certa sfiducia negli storici perché tendono a presentare
gli uomini solo in situazioni eroiche e straordinarie e si
preoccupano troppo di attribuire agli individui un’identità
univoca e rigida quale appare nei pochi momenti culminanti della
vita. “Per giudicare un uomo”, scrive Montaigne, “bisogna
stargli dietro a lungo, seguirlo con curiosità nella quotidiana vita
privata”, poiché in quella pubblica si indossano più facilmente
delle maschere.
In questa ottica è l’individuo solo e privato
che giudica il “grande uomo”, non viceversa. Quotidianità e
singolarità hanno perciò qualcosa di antisociale e delimitano uno
spazio di anti-Storia. L’uomo di Montaigne è un io che non
somiglia ai modelli del principe di Machiavelli o del cortigiano di
Castiglione, somiglia piuttosto agli autoritratti di Rembrandt:
“Altri modellano l’uomo; io lo racconto e ne rappresento un
esemplare molto malformato e tale che se dovessi modellarlo di nuovo
lo farei in verità molto diverso da quello che è. Ma ormai è
fatto. I tratti della mia pittura sono sempre fedeli, anche se
cambiano e variano. Il mondo non è che una continua altalena. Tutte
le cose vi oscillano senza posa: la terra, le rocce del Caucaso, le
piramidi d’Egitto, sia per oscillazione generale che per
oscillazione propria. Anche la costanza è solo un’oscillazione più
debole. Io non posso fissare il mio oggetto. Esso procede incerto e
vacillante (…) Non descrivo l’essere. Racconto il passaggio: non
il passaggio da un’epoca a un’altra, ma da un giorno all’altro,
di minuto in minuto (…) Se la mia anima potesse stabilizzarsi, non
mi saggerei, mi deciderei. Invece è sempre in tirocinio e in prova
(…) Tutta la filosofia morale si applica altrettanto bene a una
vita comune e privata che a una vita di stoffa più ricca. Ogni uomo
porta la forma intera dell’umana condizione” (Libro III, capitolo
2).
Dato il suo oggetto, dato il suo metodo e stile,
Montaigne propone due cose che in termini di filosofia possiamo
chiamare: a) una gnoseologia scettica che dubita continuamente di
certezze e conoscenze raggiunte; e b) un’ontologia pluralistica che
isola individui, circostanze e casi, evitando di definire
concettualmente entità generali. Invece di cercare di afferrare
l’essere al di là delle apparenze mutevoli, segue il mutamento, il
divenire, la sola cosa di cui umanamente si può fare esperienza.
Prima di David Hume e di Giacomo Leopardi, contro l’ontologia
novecentesca restaurata dalla scuola di Heidegger, quello di
Montaigne è un pensiero antimetafisico che evita la conoscenza dei
“principi primi” come non umana. Supermentale, più che mentale.
In una vita sociale e politica che si
costruisce, si tiene insieme e opera dividendosi in feroci e
permanenti conflitti fondati su convinzioni dogmatiche, Montaigne si
tira indietro, si allontana. Vede sfumature dove altri impugnano
fedi. Vivendo in una Francia devastata dallo scontro fra Lega
cattolica e Ugonotti, questo benestante signore altoborghese sceglie
di dedicarsi alla lettura e a un suo particolare genere di filosofia
autobiografica.
L’idea della morte lo assillava e non senza
ragione. Nel 1563, quando aveva trent’anni, era morto di peste il
suo migliore amico Etienne de la Boétie. Cinque anni dopo morì suo
padre. L’anno successivo il suo fratello minore fu vittima di un
mortale incidente sportivo. Il suo primo figlio morì a due anni. In
seguito, dei suoi cinque figli ne sopravvisse uno. La Francia
pullulava di banditi, tra una guerra civile e un’altra. Lui stesso
ebbe un grave incidente andando a cavallo e fu per qualche ora in
pericolo di vita. Nel corso degli anni passerà dall’idea del
filosofare come un “imparare a morire” a una diversa saggezza:
“non preoccuparsi della morte”, ci penserà la natura a fare
tutto.
Possiamo forse dire che nell’opera di
Montaigne troviamo la meno astrattamente ambiziosa, la più liberale,
la più democratica, moderatamente anarchica, realista e socievole
delle filosofie. I suoi Saggi si concludono con queste parole: “E’
una perfezione assoluta, quasi divina, saper godere lealmente del
proprio essere (…) abbiamo un bel montare sui trampoli, anche sui
trampoli dobbiamo camminare sulle nostre gambe. E sul più alto trono
del mondo non siamo seduti che sul nostro culo. Le vite più belle
sono, secondo me, quelle che si conformano al comune modello umano,
con ordine: ma senza eccezionalità e senza stravaganza”.
Il primo dei moderni avrebbe condannato grande
parte della futura modernità.