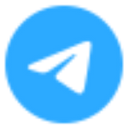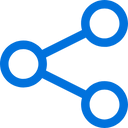“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.” Antonio Gramsci
26 aprile 2024
IL 27 APRILE DEL 1937 SI SPEGNE ANTONIO GRAMSCI. Aveva solo 46 anni... 1 e 2
Gramsci continua a vivere nel cuore di milioni di uomini (fv)
"EREDITA' DISSIPATE" A PALERMO NELLA LIBRERIA MILLE MONDI
Libreria Mille Mondi di Palermo: si presenta "Eredità dissipate" di Francesco Virga
- Libreria Mille Mondi, via Mariano Stabile 233 - Palermo
- 30 aprile 2024
- 18.00
- Gratuito (fino a esaurimento posti)
Il volume studia l'eredità di Gramsci nella vita culturale della seconda metà del Novecento e viene presentato dall'autore insieme ad Aldo Gerbino e Rino Marotta.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
E' PERICOLOSO CHIAMARE LE COSE CON IL LORO NOME
EINSTEIN SUL POTERE DELLA STAMPA
PASOLINI PROFETA INASCOLTATO
"So che sto dicendo delle cose gravissime. D’altra parte era inevitabile. Se no cosa sarei venuto a fare qui? Io vi prospetto – in un momento di giusta euforia delle sinistre – quello che per me è il maggiore e peggiore pericolo che attende specialmente noi intellettuali nel prossimo futuro. Una nuova “trahison des clercs”: una nuova accettazione; una nuova adesione; un nuovo cedimento al fatto compiuto; un nuovo regime sia pure ancora soltanto come nuova cultura e nuova qualità di vita. Vi richiamo a quanto dicevo alla fine del paragrafo quinto: il consumismo può rendere immodificabili i nuovi rapporti sociali espressi dal nuovo modo di produzione “creando come contesto alla propria ideologia edonistica un contesto di falsa tolleranza e di falso laicismo: di falsa realizzazione, cioè, dei diritti civili”.
LA DESTRA CHE SI DICHIARA FASCISTA
La destra che si dichiara fascista

Ho partecipato a un dibattito televisivo per dire tre cose sul pessimo rapporto che la destra italiana ha con la Storia. Volevo dire solo queste tre cose e le avevo comunicate prima di andare in onda.
La prima. Se il fascismo è nato in Italia significa che da noi c’è un terreno fertile.
La seconda. Il fascismo che non è finito il 25 aprile ’45 è: le stragi dal 12 dicembre del ’69 al 2 agosto dell’80, i tentati colpi di Stato del ’64 e del ’70, la P2.
La terza. Alla fine della guerra i fascisti non furono processati. Né i fascisti e fascistelli graziati dalle amnistie, né soprattutto gli oltre mille criminali di guerra che hanno fatto stragi nelle colonie africane e nei territori occupati con particolare scandalo per la Jugoslavia. Celebriamo quattromila morti nelle foibe per dimenticare centinaia di migliaia di morti ammazzati dall’esercito dell’Italia fascista?
Ho partecipato a DiMartedì (programma settimanale di La7) per dire precisamente quello che ho dichiarato prima di entrare in studio. Appena ho ricordato il numero di 1milione 706mila jugoslavi ammazzati dai nazifascisti Massimo Magliaro mi ha interrotto. Visto che due minuti prima Bocchino si era lamentato dicendomi che se lo interrompevo… ero fascista, ho chiesto a Bocchino di definire fascista anche Magliaro. Dal video si vede che stavo scherzando, ma Magliaro mi ha preso sul serio. “La risposta è arrivata subito ed è stata forte”, scrive il Tempo, e lui si è dichiarato fascista.
Anche i giornali di destra hanno detto tutti la stessa cosa. Non hanno smentito. Si sono lamentati, hanno ironizzato, l’hanno buttata in caciara, ma tutti hanno preso atto che un esponente della destra italiana ha la faccia tosta di andare in tv e dichiararsi fascista “senza alcun tentennamento” come scrive il Giornale.
Su LIBERO la raccontano così: «L’attore Celestini prende di mira Magliaro e afferma durante un diverbio: “Allora lei è fascista…”. La risposta è fulminante: “Lo sono, chiama i carabinieri?”»
Sul TEMPO: «L’attore Celestini ha messo nel mirino Massimo Magliaro: “Allora lei è fascista”, ha chiesto in diretta tv al suo interlocutore. La risposta è arrivata subito ed è stata forte: “Lo sono, chiama i carabinieri”»
Il migliore è IL GIORNALE che scrive nel titolo: «A DiMartedì scatta l’interrogatorio sull’antifascismo”». E argomenta con: «Sono passati pochissimi attimi e Magliaro, senza alcun tentennamento, ha rivendicato le proprie posizioni e ha lanciato una domanda provocatoria verso lo scrittore: “Io sì, lo sono. E allora?”».
F. FORTINI, C' era una donna che sola ho amato...
25 aprile 2024
LA SEDUZIONE EROTICA NELLA LETTERATURA DEL 900
[E’ uscito da poco per Carocci Professori di desiderio. Seduzione e rovina nel romanzo
del Novecento, di Valentina Sturli. Pubblichiamo un estratto del
primo capitolo].
SEDUZIONE E ROVINA NEL ROMANZO DEL 900
Valentina Sturli
Ai primi del Duecento si diffonde in Europa una leggenda, quella di
Aristotele cavalcato da Fillide, che avrà fortuna per tutto il Medioevo. Chi
sia Aristotele è ben noto, ed era noto a maggior ragione nel Medioevo: non è un
caso che Dante, senza neanche doverlo nominare, lo chiami «il maestro di color
che sanno» (Inferno iv, 131) e lo metta a guida degli Spiriti
Magni. Aristotele è per antonomasia il più sapiente di tutti. E Fillide chi è?
Qui le versioni divergono: amante, cortigiana, moglie – è una donna legata a un
principe, che in molta parte della tradizione viene identificato con Alessandro
Magno, di cui Aristotele è il maestro. Secondo la storia, Alessandro trascura i
doveri del regno perché innamorato di lei; Aristotele cerca allora di
convincere il discepolo a temperare i suoi ardori, che lo allontanano dalle incombenze
di governante. Alessandro cede, e accetta di diradare gli incontri con la
donna, che architetta una vendetta esemplare: seduce Aristotele, per mostrare
che anche l’anziano sapiente non è immune dalla forza dell’amore.
Nel Lai di Aristotele di Henri d’Andeli, composto verso la
metà del xiii secolo, la scena di seduzione è rappresentata icasticamente: di
prima mattina il dotto è chiuso dentro al suo studio, mentre Fillide è fuori
nel sole, circondata degli elementi riconducibili alla primavera e al più
classico di tutti i topoi, il locus amoenus. Prima
tramite la voce, e poi attraverso la vista, la ragazza riesce a farsi notare.
C’è una finestra che inquadra la scena e funziona da soglia tra spazio chiuso e
aperto, tra ombra e luce, tra sicurezza e ignoto […]. Nel momento in cui la
vista della bella colpisce gli occhi del dotto, come topica amorosa insegna,
non c’è più scampo: Aristotele si affaccia alla finestra, parla con lei. Dopo
un breve e goffo corteggiamento, infiammato di desiderio, le chiede di entrare.
Ma qui assistiamo a un ribaltamento, perché sarà Fillide a dettare le
condizioni. Appena acquisito, mediante la seduzione erotica, il potere di
dirigere i pensieri dell’amante, la donna fa infatti scattare la trappola; dice
al sapiente che accetterà di essere sua solo a patto che lui si lasci bardare e
cavalcare. […] Ma la ragazza ha già avvertito Alessandro di trovarsi a una
certa ora proprio lì: quando Aristotele, accecato di desiderio, accetta di
sottoporsi alla prova degradante per conquistare le grazie di Fillide, scopre
che il suo sovrano lo guarda. Alessandro coglie sul fatto la scena e, a seconda
delle diverse leggende, il tutto ha un esito più o meno comico, misogino o
moralistico: ad ogni modo il maestro, sorpreso con le mani nel sacco, dichiara
di aver fatto bene a mettere il discepolo in guardia contro l’amore e le donne.
Se pure un vecchio sapiente come lui cede alle lusinghe e si degrada a tal
punto, a quali disastri può condurre la potenza delle passioni in un giovane?
Siamo davanti all’ammissione dell’avvenuto rovesciamento delle parti: chi aveva
la presunzione di saper governare le proprie passioni tanto da poter
ammaestrare anche gli altri è caduto miseramente nella trappola delle medesime.
È interessante notare come più di sette secoli dopo, tra fine Ottocento e
Novecento, una serie di narrazioni riprenderà con una certa insistenza questo
stesso tema, ovvero quello di un intellettuale che viene soggiogato suo
malgrado dalla potenza seduttiva di un oggetto del desiderio che lo conduce su
una strada pericolosa e inquietante. Il ventennio che va tra la fine del xix
secolo e l’inizio della Prima guerra mondiale costituisce per la storia europea
un punto di svolta cruciale: in quel giro di anni la fisionomia del mondo
occidentale cambia radicalmente, e non soltanto a livello geo-politico, con il
crollo degli imperi ottomano, russo e austro-ungarico, e la serie di eventi che
innescheranno il primo conflitto mondiale. Tra fine dell’Ottocento e inizio del
Novecento Freud inventa la psicoanalisi, Nietzsche decreta che Dio è morto, la
fisica apre nuove dimensioni della materia. La crisi epistemologica che ne
deriva è foriera di conseguenze epocali, soprattutto per una classe – quella
degli intellettuali – tanto coinvolta in prima linea nella definizione di
questa medesima crisi, quanto incapace di scongiurarne le conseguenze per gli
altri e per sé stessa. E proprio nel primo ventennio del secolo si manifesta
con insistenza nella letteratura europea una costellazione di narrazioni che
rappresentano esponenti della ragione (o supposti tali) che subiscono l’onda
d’urto di un desiderio amoroso che li spinge bruscamente fuori dai consueti
binari della loro vita ordinaria. Sulle tracce di desideri inaspettati e inquietanti,
questi personaggi si trovano all’improvviso, e quasi senza avvedersene, a dover
fare i conti con una realtà che sfugge, si rivela imprendibile e oscura. Ma
soprattutto che resiste ai loro sforzi ermeneutici, li confonde e non si fa più
decifrare.
Il tema non sarà più trattato in modo così leggero e giocoso, non avrà
sempre per protagonisti un uomo anziano e una donna, potrà variare, e
soprattutto potrà avere esiti di volta in volta più o meno tragici, ma nella
storia di Aristotele e Fillide c’è un nucleo semantico che potremmo riassumere
così: un sapiente, incarnazione di un’autorità morale e intellettuale,
investito di una funzione didattica o pedagogica riconosciuta dalla società,
cede al potere attrattivo di un oggetto del desiderio posto più in basso di
lui; questo cedimento innesca un processo di incontro/scontro con l’alterità
che lo conduce alla rovina e al degrado. Nel finale della leggenda medievale,
Aristotele si limita a dare la colpa della sua brutta figura ai guasti che può
produrre l’amore, e contro l’etica stoica, che predica il dominio di sé e
l’esercizio razionale della virtù, è anche troppo evidente la morale cristiana:
è meglio non fidarsi mai troppo della propria presunzione di autocontrollo,
perché il disastro è sempre in agguato quando si tratta dello scatenamento
delle passioni. Solo una vigilanza costante può mettere al riparo da cadute
vertiginose dovute ai sensi, anche quando per età, sapienza, dottrina si
potrebbe avere la tentazione di ritenersi al sicuro.
A voler definire un prototipo del nostro tema, niente funziona meglio di un
romanzo che si imporrà nell’immaginario soprattutto grazie a un fortunatissimo
adattamento cinematografico: Il professor Unrat (1905) di
Heinrich Mann, che costituirà la base per L’Angelo Azzurro (1930)
di Josef von Sternberg. Il titolo del romanzo contiene un gioco di parole, che
anticipa una polarità fondamentale per tutti i nostri testi: da un lato il
professore, che rimanda a una valenza semantica di prestigio; dall’altro Unrat che
significa “rifiuto”. Il senso è qualcosa di simile a “Professor Spazzatura”,
perché il protagonista si chiama Raat, ma è talmente odiato dai suoi allievi da
meritarsi questo nomignolo. Siamo nel Nord della Germania guglielmina, a fine
Ottocento, in una ricca e bigotta cittadina anseatica. Il protagonista è un
arcigno docente di Greco del liceo locale, invecchiato tra le sue scartoffie e
inviso agli allievi per via dell’arbitraria tirannide che esercita. Ben più che
come trasmissione del sapere, intende la sua missione come una lotta per
cogliere in fallo i ragazzi; la sua idea di cultura è quanto di più
nozionistico e ottuso si possa immaginare.
Un giorno Unrat scopre che tre dei suoi allievi più odiati vanno ogni sera
nel camerino di una cantante da avanspettacolo, Rosa Fröhlich, che si esibisce
in un locale del porto, l’Angelo Azzurro, e decide di sorprenderli in
flagrante. La sera stabilita si mette in cammino per le strade della città,
addentrandosi in luoghi che non conosce. Una volta messosi sulle tracce del
vizio, il professore comincia un percorso di smarrimento nello spazio che
prelude a uno morale, con un’associazione semantica che si rivelerà pervasiva
in tutti i testi che analizzeremo. […] L’effetto di Rosa, ancora sconosciuta, è
già quello di trarre Unrat fuori dal binario della sua esistenza; il cronotopo
di un notturno tra vicoli stretti, male illuminati e malfamati, in questo senso
parla chiarissimo. Nel suo peregrinare il professore è sospeso tra sentimenti
contrastanti: si sente perduto e smarrito, ma è anche stranamente eccitato, e
dopo un po’ prende gusto alla caccia. Il momento in cui entra a capofitto nella
bettola, proprio là dove incontrerà Rosa e il suo destino, viene descritto come
il gettarsi dentro un abisso; lo stesso avverrà nel finale del romanzo, quando
la polizia lo va a catturare. Davanti all’Angelo Azzurro Unrat decide di
entrare, e come nel più classico dei contrappassi, chi è andato per
intrappolare sarà intrappolato. […]
Già in questo primo esempio sono evidenti elementi che delimiteranno la
nostra serie e torneranno sistematicamente: la presenza di un intellettuale
(che può essere già più o meno degradato in partenza) che alle prese con
l’alterità radicale di un oggetto del desiderio posto più in basso di lui (che
sia di sesso femminile o maschile poco importa) entra in crisi, dando il via ad
un processo di erranza che spesso ha le caratteristiche di un vero e proprio
vagabondaggio nello spazio, ma che presto si traduce in un percorso di
smarrimento mentale e morale. Ciò conduce a una crisi che può tradursi in
un’evoluzione o nella morte. Naturalmente non sono solo i vecchi filosofi e i
professori bigotti a deragliare per colpa del desiderio amoroso, poiché
l’intera letteratura occidentale si regge sulla rappresentazione dei danni cui
può condurre la perdita di controllo su di sé, in particolar modo quella
dettata dall’istinto amoroso con il suo corollario di possessività e gelosia.
Ma ciò che indagheremo sarà l’ultima declinazione di un tema che viene da
lontano, e che affonda le sue radici nella critica alla presunzione della
razionalità di governare il mondo e le passioni; nei testi novecenteschi gli
esiti saranno quasi sempre infausti, ma al di là del disastro potranno portare
a un faticoso processo di conoscenza di sé da parte di chi credeva,
erroneamente, di avere già tutte le coordinate per orientarsi nel mondo. […] Se
nell’antichità a impedire la caduta erano i valori relativi al codice eroico, e
per l’epoca cristiana la fede in un dio trascendente, tra la fine del
Settecento e l’inizio del secolo successivo, portate a compimento le premesse
della rivoluzione dei Lumi, l’eroe – diventato nel frattempo eroe della ragione
– non potrà più contare che sul suo intelletto per far fronte alle tentazioni
di un’alterità seduttiva e minacciosa. Affrontare il tema che possiamo definire
dell’intellettuale che si degrada per amore significa, dunque, prima di tutto
interessarsi a casi in cui la ragione di matrice kantiana, quella che si fonda
solo su sé stessa e sulla forza morale di chi la possiede, viene messa in
pericolo da tentazioni di tipo erotico-sentimentale. Se si ammette che la
letteratura funzioni come sede di un ritorno del represso di tutte quelle
istanze che in una certa epoca storica sono malviste, ignorate, negate, non
sarà un caso che il nostro tema cominci a manifestarsi con insistenza proprio
tra fine Ottocento e inizio Novecento, in quel particolare momento della storia
culturale occidentale in cui l’ideologia dominante è permeata dal trionfo della
ragione intellettuale, ma anche dai presupposti della sua inesorabile crisi.
Se Kant ha scritto che l’Illuminismo è l’età dell’autonomia di uno spirito
che si è emancipato da una condizione di minorità e sudditanza, di cessione
all’altro della propria autonomia, possiamo ipotizzare che il tema di cui ci
occuperemo racconti il rovescio di questa autonomia, che dovrebbe essere
incarnata per antonomasia dalla figura dell’intellettuale. L’antitesi non sarà
più quella tra fedeltà a oggetti metafisici e tentazione di adorarne altri
terreni e degradati, ma piuttosto tra fedeltà alla ragione critica e alla
propria disciplina di vita, e sottomissione a oggetti che richiedono, almeno in
qualche grado, un’abiura di esse. In questa prospettiva si può affermare che un
certo tipo di polarizzazione semantica, attiva da lunghissima data nella narrativa
occidentale, si è declinata in modi diversi a seconda dei momenti e dei testi.
[…] Nella nostra serie di testi il rapporto con l’alterità si renderà figura di
un rapporto mutato col mondo, e di nuove sfide ermeneutiche a cui gli esponenti
della razionalità e della morale saranno sempre meno in grado di far fronte in
un’età di profondissima crisi. Il problema non sarà costituito tanto dal fatto
che l’oggetto d’amore si rifiuta di riamare chi lo ama, quanto piuttosto che
chi è amato sfugge all’amante sul piano conoscitivo, è opaco, mette in crisi le
facoltà interpretative di chi dovrebbe essere chiamato a esercitarle per
guidare gli altri.
Il campione di romanzi che esamineremo in questa luce non sarà esaustivo,
ma vuole essere in qualche grado emblematico; sono tutti testi molto noti del
canone, e appartengono a un sottoinsieme che potremmo definire
dell’intellettuale che si rovina per amore, che a sua volta fa parte
dell’insieme molto più ampio di testi che parlano del degrado per amore puro e
semplice. Dovendo decidere come trattarli, in un primo tempo si è pensato al
semplice ordine cronologico, che rende bene l’idea dell’arco temporale – quasi
un secolo esatto – in cui si iscrive la nostra indagine: il primo è Senilità di
Italo Svevo, pubblicato nel 1898, l’ultimo è Il contagio di
Walter Siti, del 2008. Ma via via che la stesura del volume procedeva, si è
fatta avanti in chi scrive la convinzione che, pur mantenendo un certo ordine
cronologico che fa sì che testi primo-novecenteschi siano trattati prima di
quelli secondo-novecenteschi, bisognasse almeno in parte sparigliare le carte:
pur rispondendo tutti a un impianto comune, alcuni romanzi rivelavano
particolari affinità con altri. In certi casi l’affinità era scontata, sia per
contiguità cronologica sia per rapporti intercorsi tra gli autori, attivi negli
stessi anni (è il caso paradigmatico di André Gide e di Thomas Mann); altre
volte l’accostamento è favorito dall’appartenenza a una comune tradizione
letteraria, che prevede una filiazione diretta (si veda uno per tutti il rapporto
che sia Un amore di Dino Buzzati sia La noia di
Alberto Moravia, usciti in un brevissimo giro di anni, intrattengono con Senilità).
Ma ci sono anche testi per cui un rapporto di parentela o di influenza diretta
è altamente improbabile: si pensi a coppie come L’odore del
sangue di Goffredo Parise e Follia di Patrick McGrath
che, per quanto distanti, pure presentano delle sorprendenti affinità. Si è
dunque deciso (tranne nel caso di Lolita di Vladimir Nabokov,
snodo talmente centrale e paradigmatico per la nostra costellazione da meritare
una trattazione a sé stante) di procedere analizzando i testi a coppie sulla
base di affinità che saranno di volta in volta discusse, e che possono risultare
illuminanti ben al di là degli steccati tra letterature nazionali e tradizioni
letterarie diverse. Questo nella convinzione che i testi letterari possano a
volte non solo essere i migliori interpreti di sé stessi, ma anche di altri cui
li legano curiose e inaspettate parentele.
René Girard (2009, p. 43) ha scritto che «i romanzi si chiariscono gli uni
per mezzo degli altri e la critica dovrebbe attingere ai romanzi stessi i
propri metodi e persino il senso del suo sforzo»; nell’accostare testi scritti
da autori diversi in epoche non sempre contigue, nel provare a leggerli in
parallelo e in una serie che da fine Ottocento arriva fino ai giorni nostri,
abbiamo provato a far parlare i testi tra di loro, sperando che ci rivelino
qualcosa della trama delicata e complessa che costruiscono del mondo e nel
mondo. Una trama sempre a rovescio, che va disciolta e ricomposta ogni volta
cercando di non fare troppa violenza all’armonia del suo insieme.
[Immagine: Edvard Munch, La separazione].
UOMINI E NO
Sottoscrivo quanto detto oggi dal Prof. Antonio Di Grado a proposito di antifascismo (fv):
ESSERE ANTIFASCISTI OGGI
L’ antifascismo, dunque: un
pregiudizio da liquidare o piuttosto una discriminante da mantenere? Ed è in
crisi, quel patrimonio di memorie e di valori? Pare di sì, a dar retta a chi
predica una sorta di pacificazione, a chi vorrebbe una memoria edulcorata e
così, finalmente, “condivisa”. E invece un paese maturo può, forse deve, fare i
conti con una memoria divisa.
Non c’è nazione moderna che non sia
nata da un cruento rivolgimento, politico o religioso, che l’ha spaccata in
due: la Riforma protestante, la guerra civile inglese, la Rivoluzione francese,
la guerra di secessione americana; per noi le due grandi occasioni mancate
della nostra breve storia: il Risorgimento democratico e la Resistenza
antifascista. E non c’è democrazia autentica (ma ce ne sono ancora?) che non si
fondi sopra nette scelte di campo, o appassionate professioni di fede. È a
questo prezzo che la bandiera abolizionista di Abramo Lincoln, insanguinata da
una guerra civile, passò nelle mani inermi di Martin Luther King. Disse un
protagonista di quella guerra: «Non ci dev’essere chiesto di dire che non c’era
alcuna differenza fra coloro che combatterono per l’Unione e coloro che
combatterono contro»; e così dovremmo dire noi agli odierni affossatori della
memoria, giornalisti e politici, di destra e di sinistra.
E non ha senso nemmeno una visione
troppo lineare – e pacificatrice - del percorso che ha fatto dell’Italia
sabauda un’Italia repubblicana. Nella storia, invece, non tutto è positivo, la
storia non ha mai conosciuto “magnifiche sorti e progressive”, e tantomeno la
storia di un’Italia che già sul nascere aveva visto offuscarsi la sua prima
grande occasione, quell’agognata unità nella libertà. In quella storia la
Resistenza fu un elemento di rottura, non di continuità: segnò, anzi, una
discontinuità radicale nella storia d’Italia. Fu la seconda grande occasione di
rinnovamento: disattesa, rinnegata anch’essa sul nascere; e oggi tristemente
archiviata, confusa in una indistinta nebulosa assieme a Muzio Scevola e a
Pietro Micca. Basta guardarsi intorno, interrogare la gente, come basta a me
interrogare i miei allievi, quasi tutti salvo un’élite politicizzata
indifferenti o ignari, per accorgersi che nell’ultimo scorcio del secolo scorso
si è aperta una cesura, che ha allontanato e appiattito il passato e ha azzerato
la memoria.
Antifascismo, dunque, come
principio indispensabile. Come la memoria, dolorosamente ma necessariamente
“divisa”. È la ferma risposta del commissario partigiano Kim del "Sentiero
dei nidi di ragno" di Italo Calvino al compagno che insinuava: «Quindi, lo
spirito dei nostri… e quello della brigata nera… la stessa cosa?...». C’era
purezza e ferocia, c’era pietà e cieca violenza da una parte e dall’altra, è
vero, ma Kim risponde: «la stessa cosa ma tutto il contrario. Perché qui si è
nel giusto, là nello sbagliato». Quel «peso di male», quel «furore antico» che
i partigiani sfogano in battaglia, «è lo stesso che fa sparare i fascisti, che
li porta a uccidere con la stessa speranza di purificazione, di riscatto», ma…
«Ma allora c’è la storia. C’è che noi, nella storia, siamo dalla parte del
riscatto, loro dall’altra». E così la discriminante è tracciata, a futura
memoria. «Da noi – prosegue Kim –, niente va perduto», mentre l’altra «è la
parte dei gesti perduti, degli inutili furori», che «non fanno storia».
Calvino scrive nel ’47, appartiene
alla giovane generazione sbocciata col neorealismo, ma già alla fine degli anni
’30 Elio Vittorini, che apparteneva alla generazione precedente, quella del
“lungo viaggio attraverso il fascismo”, un viaggio tortuoso e drammatico che da
un generico e velleitario ribellismo giovanile, dall’illusione d’un fascismo
rivoluzionario e anticapitalista l’aveva condotta alla scoperta della vera
natura – dispotica, reazionaria, padronale, normalizzatrice, repressiva – del
regime, e a un’inquieta ricerca di nuovi approdi ideologici, nella sua
"Conversazione in Sicilia" scopriva che «forse non ogni uomo è uomo;
e non tutto il genere umano è genere umano. (…) Un uomo ride e un altro piange.
Tutti e due sono uomini; anche quello che ride è stato malato, è malato; eppure
egli ride perché l’altro piange. Egli può massacrare, perseguitare, e uno che
(…) lo vede che ride sui giornali, non va con lui che ride ma semmai piange,
nella quiete, con l’altro che piange. Non ogni uomo è uomo, allora. Uno
perseguita e uno è perseguitato; e genere umano non è tutto il genere umano, ma
quello soltanto del perseguitato».
"Uomini e no" si chiamerà
infatti il suo successivo romanzo, quello del ’45 sulla Resistenza a Milano:
una antitesi che oggi può apparire manichea, oggi ragioneremmo in maniera più
complessa, meno astratta, cercheremmo di capire piuttosto che cosa fa
dell’umanità – per dirla con Eco – dell’Ur-fascismo, del fascismo eterno, di
quella nebulosa di odio e ignoranza che oggi ci sommerge, quello che è, che è
diventata o che forse già era, ma allora quella drastica antinomia, quella
discriminante così nettamente divisiva, si imponeva, e non furono certo gli
scrittori, gli intellettuali a edulcorarla, a conciliare, a ricomporre.
Semmai Cesare Pavese, nella
"Casa in collina", così scriveva: «ho visto i morti sconosciuti, i
morti repubblicani. […] Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa
simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto
il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare
una voce a questo sangue, giustificare chi l’ha sparso. […] Per questo ogni
guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede
ragione. […] Io non credo che possa finire. Ora che ho visto cos’è la guerra,
cos’è guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi:
“E dei caduti che facciamo? perché sono morti?”. Io non saprei cosa rispondere.
Non adesso, almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno
unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero».
Occorre “placare” il sangue, anche
quello nemico; occorre “perdonare”. Ma attenzione, lo scrive anche Eco,
«perdonare non significa dimenticare». La pietas, cristiana o laica che sia,
per chi è caduto, per chi ha creduto, per chi si è scommesso in buona fede in
una causa sbagliata, non esclude affatto il giudizio, etico e politico,
necessariamente inflessibile, non autorizza affatto l’impulso di dimenticare,
perché la guerra non è finita, dice anzi Pavese: «Io non credo che possa
finire», né la ferita può sanarsi con il balsamo dell’indifferenza, con il
lenitivo dell’indistinzione.
"Uomini e no" si chiamerà
infatti il suo successivo romanzo, quello del ’45 sulla Resistenza a Milano:
una antitesi che oggi può apparire manichea, oggi ragioneremmo in maniera più
complessa, meno astratta, cercheremmo di capire piuttosto che cosa fa
dell’umanità – per dirla con Eco – dell’Ur-fascismo, del fascismo eterno, di
quella nebulosa di odio e ignoranza che oggi ci sommerge, quello che è, che è
diventata o che forse già era, ma allora quella drastica antinomia, quella
discriminante così nettamente divisiva, si imponeva, e non furono certo gli
scrittori, gli intellettuali a edulcorarla, a conciliare, a ricomporre.
Semmai Cesare Pavese, nella
"Casa in collina", così scriveva: «ho visto i morti sconosciuti, i
morti repubblicani. […] Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa
simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto
il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare
una voce a questo sangue, giustificare chi l’ha sparso. […] Per questo ogni
guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede
ragione. […] Io non credo che possa finire. Ora che ho visto cos’è la guerra,
cos’è guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi:
“E dei caduti che facciamo? perché sono morti?”. Io non saprei cosa rispondere.
Non adesso, almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno
unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero».
Occorre “placare” il sangue, anche
quello nemico; occorre “perdonare”. Ma attenzione, lo scrive anche Eco,
«perdonare non significa dimenticare». La pietas, cristiana o laica che sia,
per chi è caduto, per chi ha creduto, per chi si è scommesso in buona fede in
una causa sbagliata, non esclude affatto il giudizio, etico e politico,
necessariamente inflessibile, non autorizza affatto l’impulso di dimenticare,
perché la guerra non è finita, dice anzi Pavese: «Io non credo che possa
finire», né la ferita può sanarsi con il balsamo dell’indifferenza, con il
lenitivo dell’indistinzione.
ANTONIO DI GRADO
DISCORSO DI PIERO CALAMANDREI ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE
ATTENZIONE A NON TRADIRE CHI HA COMBATTUTO CONTRO IL FASCISMO
di Piero Calamandrei
[Pubblichiamo un estratto del discorso che Piero Calamandrei tenne all’Assemblea Costituente il 4 marzo 1947. Buon 25 aprile].
C’è nelle disposizioni transitorie, del progetto, un articolo che proibisce «la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista».
Non so perché questa disposizione sia stata messa fra le transitorie: evidentemente può essere transitorio il nome «fascismo», ma voi capite che non si troveranno certamente partiti che siano così ingenui da adottare di nuovo pubblicamente il nome fascista per farsi sciogliere dalla polizia. Se questa disposizione deve avere un significato, essa deve esser collocata non tra le disposizioni transitorie, e non deve limitarsi a proibire un nome, ma deve definire che cosa c’è sotto quel nome, quali sono i caratteri che un partito deve avere per non cadere sotto quella denominazione e per corrispondere invece ai requisiti che i partiti devono avere in una Costituzione democratica. Sarà la organizzazione militare o paramilitare; sarà il programma di violenze contrario ai diritti di libertà; sarà il totalitarismo e la negazione dei diritti delle minoranze: questi od altri saranno i caratteri che la nostra Costituzione deve bandire dai partiti, se veramente vuol bandire il fascismo.
[…]
Ho finito così, onorevoli colleghi, le mie osservazioni di carattere generale sulla nuova Costituzione. Vi ringrazio di avermi ascoltato con tanta benevolenza e così a lungo.
Vedete, colleghi, bisogna cercare di considerare questo nostro lavoro non come un lavoro di ordinaria amministrazione, come un lavoro provvisorio del quale ci si possa sbrigare alla meglio. Qui c’è l’impegno di tutto un popolo. Questo è veramente un momento solenne. Sento un certo ritegno, un certo pudore a pronunziare queste grandi parole: si fa presto a scivolare nella retorica. Eppure qui veramente c’è nelle cose questa solennità, e non si può non sentirla; questa solennità che non è fatta di frasi adorne, ma di semplicità, di serietà e di lealtà: sopratutto di lealtà.
Questo che noi facciamo è il lavoro che un popolo di lavoratori ci ha affidato, e bisogna sforzarci di portarlo a compimento meglio che si può, lealmente e seriamente. Non bisogna dire, come da qualcuno ho udito anche qui, che questa è una Costituzione provvisoria che durerà poco e che, di qui a poco, si dovrà rifare. No: questa dev’essere una Costituzione destinata a durare.
Dobbiamo volere che duri; metterci dentro la nostra volontà. In questa democrazia nascente dobbiamo crederci, e salvarla così con la nostra fede e non disperderla in schermaglie di politica spicciola e avvelenata.
Se noi siamo qui a parlare liberamente in quest’aula, in cui una sciagurata voce irrise e vilipese venticinque anni fa le istituzioni parlamentari, è perché per venti anni qualcuno ha continuato a credere nella democrazia, e questa sua religione ha testimoniato con la prigionia, l’esilio e la morte.
Io mi domando, onorevoli colleghi, come i nostri posteri tra cento anni giudicheranno questa nostra Assemblea Costituente: se la sentiranno alta e solenne come noi sentiamo oggi alta e solenne la Costituente Romana, dove un secolo fa sedeva e parlava Giuseppe Mazzini. Io credo di sì: credo che i nostri posteri sentiranno più di noi, tra un secolo, che da questa nostra Costituente è nata veramente una nuova storia: e si immagineranno, come sempre avviene che con l’andar dei secoli la storia si trasfiguri nella leggenda, che in questa nostra Assemblea, mentre si discuteva della nuova Costituzione Repubblicana, seduti su questi scranni non siamo stati noi, uomini effimeri di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma sia stato tutto un popolo di morti, di quei morti, che noi conosciamo ad uno ad uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e nelle pianure, nelle steppe russe e nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovinetti partigiani, fino al sacrificio di Anna-Maria Enriquez e di Tina Lorenzoni, nelle quali l’eroismo è giunto alla soglia della santità.
Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere: il grande lavoro che occorreva per restituire all’Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservata la parte più dura e più difficile; quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore.
Assai poco, in verità, chiedono a noi i nostri morti.
Non dobbiamo tradirli.
PIERO CALAMANDREI
POESIE DI LOTTA E DI RESISTENZA SCELTE DA ERRI DE LUCA
Grido, non serenata. Poesie di lotta e di resistenza
Insistendo sull’urgenza di questo 25 aprile, ospito qui alcune poesie (Ángel González, Fayad Jamís,Bertolt Brecht), di lotta e di resistenza, scelte da Erri De Luca per la raccolta Grido, non serenata, pubblicata da Crocetti. Ospito anche la sua nota introduttiva.
***
Questa raccolta risponde all’insindacabile opera del caso che qui si è manifestato in forma di scaffali affastellati di libri di poeti accumulati da mio padre, poi da me. Li ho sfogliati in cerca delle pagine da offrire, non più di qualche poesia per ogni poeta. La parola per me comprende femminile e maschile. L’ho imparato da Anna Achmatova che si dichiarava poeta e non poetessa. In russo le due parole sono uguali alle nostre. Sono pagine da condividere leggendole alla tavola di una sera che si prolunga e che lubrifica col vino le corde vocali. Sono poesie da dire, pronunciare aggiungendo il proprio fiato. Evito il verbo recitare che in parte le falsifica. Tra i dischi di mio padre alcuni erano incisioni di versi letti da attori. Calcavano coi toni della voce impostata, appunto: recitavano. Chi dice un verso muove anche le labbra di chi lo ha scritto. La poesia permette questa coincidenza e quella di ispirazione politica accomuna i sentimenti di giustizia di chi ha scritto e di chi legge. Qualche poeta è stato un incontro e mi ha ribadito nelle convinzioni. Qui ne cito uno soltanto, a nome dell’insieme. Ante Zemljar partigiano jugoslavo, prigioniero prima dei fascisti italiani poi dei suoi stessi compagni dopo la guerra, a causa di divergenze. Questa prigionia fu la peggiore, a spaccare pietre sopra l’Isola Nuda, a subire percosse di guardiani. Anche lì di nascosto, su carta da imballaggio di cemento e con un carboncino, scriveva dei versi veloci che nascondeva sottoterra. Ne sono stato amico. In questa raccolta manca per difficoltà varie, ma non manca a me. Con questa nota lo segnalo a chi vorrà cercarlo.
Ne sono stato amico. In questa raccolta manca per difficoltà varie, ma non manca a me. Con questa nota lo segnalo a chi vorrà cercarlo. Ho fatto parte di una gioventù politica che aveva dalla sua la quantità numerica e l’istruzione superiore, miscela che fu allora detonante. Ho fatto parte di una massa critica intransigente e perciò avversata con l’antico sistema delle prigioni. Cerco nei poeti il grido, non la serenata. Qui ci sono quelli che mi è capitato di raccogliere durante la mia già lunga durata. Mancano arbitrariamente tutti gli altri che chi legge potrebbe aspettarsi di trovare. La scelta è tanto occasionale quanto personale, lacunosa come si addice a chi, leggendo spesso, si è fatto un’idea di quanto ha tralasciato. Non mi sono permesso di includere alla collezione una mia poesia. Resto nelle retrovie di questo libro, da addetto al suo rifornimento.
Erri De Luca
***
Ángel González
(Oviedo 1925 – Madrid 2008)
Lo sconfitto
Dietro sono rimaste le macerie:
fumanti brandelli della tua casa,
estati incendiate, sangue disseccato,
su cui s’ingrassa – ultimo avvoltoio –
il vento.
Tu ti metti in viaggio, e vai avanti
verso il tempo detto a ragione futuro.
Perché nessuna terra
possiedi,
perché nessuna patria
è né sarà mai tua,
perché in nessun paese
può radicare il tuo cuore disabitato.
Mai – ed è così semplice –
potrai aprire un cancello
e dire solo questo: “Buongiorno,
mamma”.
Anche se effettivamente il giorno è buono,
c’è grano nelle aie,
e gli alberi
stendono verso di te i loro stanchi
rami, offrendoti
frutti e ombra per farti riposare.
Traduzione di Dario Puccini
*
Fayad Jamís
(Zacatecas, Messico 1930 – L’Avana 1988)
Per questa libertà
Per questa libertà di canto sotto la pioggia
bisognerà dar tutto
Per questa libertà di essere strettamente legati
alle salde e dolci viscere del popolo
bisognerà dar tutto
Per questa libertà di girasole aperto nell’alba di fabbriche
accese e di scuole illuminate
e di terra che scricchiola e di bambino che si sveglia
bisognerà dar tutto
Non c’è alternativa se non la libertà
Non c’è cammino che la libertà
Non c’è altra patria che la libertà
Non ci sarà poema senza la violenta musica della libertà
Per questa libertà che è il terrore
di quelli che sempre la violarono
in nome di fastose miserie
Per questa libertà che è la notte degli oppressori
e l’alba definitiva di tutto il popolo ormai invincibile
Per questa libertà che illumina le pupille infossate
i piedi scalzi
i tetti sforacchiati
e gli occhi dei bambini che vagavano nella polvere
Per questa libertà che è l’impero della gioventù
Per questa libertà
bella come la vita
bisognerà dar tutto
se fosse necessario
perfino l’ombra
e non sarà mai abbastanza.
Traduzione di Marcelo Ravoni e Antonio Porta
*
Bertolt Brecht
(Augusta, Germania 1898 – Berlino Est 1956)
Mio fratello aviatore
Avevo un fratello aviatore.
Un giorno, la cartolina.
Fece i bagagli, e via,
lungo la rotta del sud.
Mio fratello è un conquistatore.
Il popolo nostro ha bisogno
di spazio. E prendersi terre su terre,
da noi, è un vecchio sogno.
E lo spazio che s’è conquistato
è sui monti del Guadarrama.
È di lunghezza un metro e ottanta,
uno e cinquanta di profondità.
Traduzione di Ruth Leiser e Franco Fortini



.png)