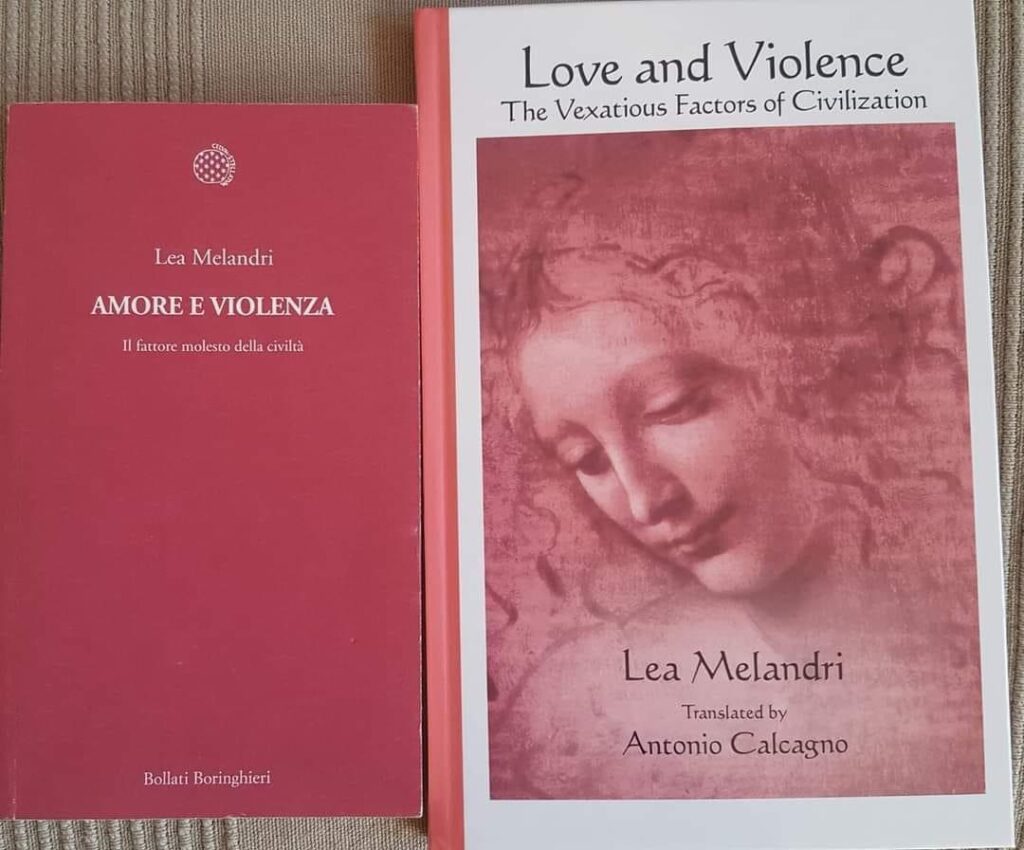Claudia Salaris, Donne di avanguardia.
di Ivana Rinaldi
È da poco uscito in libreria Donne d’avanguardia, (Il Mulino2021) di Claudia Salaris, tra le più grandi esperte e studiose italiane di Futurismo, autrice di Storia del Futurismo (Editori Riuniti, 1985) e di Le Futuriste (Edizioni delle donne, Milano, 1982). In questo volume dava spazio alle letterate, alle artiste, alle polemiste, fornendo un quadro della presenza femminile in uno dei più significativi movimenti di avanguardia dei primi anni Venti del secolo scorso. Una ricerca avviata con Pablo Echaurren, suo compagno di vita, appena usciti dai “fortunali” della politica per entrare negli “anni di piombo”. Dopo l’inasprirsi del clima, in seguito al rapimento e poi l’uccisione di Aldo Moro, racconta Salaris, trovammo nel privato e nella collezione di libri e documenti originali del futurismo la nostra zattera di salvezza.
Prese così le mosse una ricerca puntugliosa di tracce tra bancarelle, librerie antiquarie e visite ai protagonisti e alle protagoniste ancora in vita e ai loro eredi. Il risultato è la ricostruzione di numerose figure particolarmente emblematiche e su momenti di particolare discussione in cui le donne si sono pronunciate sui ruoli sessuali, la creatività e la politica. Reclamare il diritto all’espressione e all’affermazione della propria individualità, sostiene Salaris, non è secondario rispetto a quello del suffragio femminile. Il libro ci racconta di futuriste, ma non solo di loro, si concentra su esponenti del dadaismo e del realismo magico e non si limita a nomi già noti ma include nomi finora in ombra. Molte di loro erano state incluse nei lavori di Maurizio Calvesi, Enrico Crispolti, Mario Verdone, Glauco Viazzi, e in un’ottica di riflessione di genere nei lavori di Giovannella Desideri, Anna Nozzoli, Simone Weller. E fu soprattutto la mostra L’altra metà dell’avanguardia di Lea Vergine che permise di lanciare questo tema (Milano, Palazzo Reale, 14 febbraio-18 maggio 1980).
L’apertura di femministe e studiose come Maria Caronia, Manuela Fraire, Elisabetta Rasy, fondatrici delle Edizioni delle donne e ancora Biancamaria Frabotta, poeta e femminista che dirigeva L’orsa minore e la rivista Memoria, permise la pubblicazione dell’antologia Le futuriste. Il movimento fondato da Marinetti era ancora argomento tabù in certi ambienti della sinistra. Donne d’avanguardia riprende dunque e amplia quel primo lavoro sulle donne futuriste arricchindolo di figure di donne che per il loro stile di vita, pensiero, creatività, hanno lasciato un segno nell’arte, nella letteratura, nella mentalità e costumi dei tempi, rompendo tabù, luoghi comuni, pregiudizi e silenzio.

un ritratto di Valentine de Saint Point
E qui impossibile ricordarle tutte. Accenno solo almeno alle più conosciute, prima fra tutte Valentine De Saint-Point, la prima futurista.
Non dimentichiamo che Filippo Tommaso Marinetti aveva inserito nei punti programmatici del Manifesto edito da Le Figarò il “disprezzo per la donna”, una dichiarazione scandolosa che suscitò immediate polemiche. Corso ai ripari, l’autore dichiarò che il disprezzo riguardava l’eterno femminimo come unica fonte di ispirazione letteraria e la visione ossessiva dell’amore a cui andavano soggetti i popoli latini. Sebbene l’affermazione di Marinetti potesse sembrare più uno slogan pubblicitario che una sua reale visione della donna, all’epoca si proiettavano due immagini: quella della femmina istintiva, priva di doti intellettuali, prossima alla natura, una concezione ampiamente diffusa nella cultura influenzata dal pensiero maschile, Arthur Scophenauer, Friedrich Nietzche, Paul Julius Möbius, Otto Weinenger, che ne calcola addirittura la carenza intellettuale in percentuali, fino a Karl Kraus; dall’altro quello dell’eterno femminino codificato dal pretrarchismo al romanticismo, fino a D’Annunzio.
All’inizio del Novecento, la francese Anne Jeanne Valentine Marianne Desglous De Cassiat- Vercell, nata a Lione nel 1875, in arte Valentine De Saint- Point, a Parigi conobbe il mileu della nuova cultura, rompe i canoni tradizionali con le sue poesia e la sua produzione letteraria enunciando un modello di donna sessualmente liberata. Di lei rimane Una donna e il desiderio, in cui mette a fuoco il tema dell’erotismo femminile.
Nel 1912, mentre i pittori futuristi esponevano a Parigi, Marinetti riuscì a convertirla al suo credo. Tra i due nacque una liason amorosa e Valentine concepì il Manifesto della donna futurista. Rispose a F.T. Marinetti, introducendo l’idea di femminilità e mascolinità, qualita di cui uomini e donne sono in possesso: “ogni superuomo (…) è composto da elementi femminili e da elementi maschili, cioè un essere “completo”. Confluivano nel testo le teorie dell’androgino di Péladon. E così, nell’individuare prototipi femminili antogonisti a quella della donna borghese, Valentine recuperava le eroine del mito e della storia: le Erinni, le Amazzoni, Semiramide, Giovanna D’Arco, Giudette Carlotta Corday, Cleopatra, Messalina, le guerriere che a suo avviso combatterono più ferocemente dei maschi. Il punto essenziale della sua analisi era rivendicare la liberta sessuale per tutti: eterosessuali e omosessuali.
La difesa dell’omosessualità faceva parte di un sentire comune sia alla poeta che a Marinetti, che aveva già stigmatizzato la condanna a Oscar Wilde. Nel 1913 Valentine De Saint-Point era stata inserita da Apollinaire nel mileu dell’avanguardia internazionale con il suo manifesto L’antitradizione futurista.
Il primo nucleo di futuriste si costituì in piena guerra intorno alla rivista fiorentina L’Italia futurista (1916-1918), di cui l’animatrice è Maria Ginnanni, dove si riuniva un cenacolo di donne: Mari Carbonaro, Mina Della Pergola, Fanny Dini, Fulvia Giuliani, Magamal, Enrica Piubellini, Enif Robert, Rosa Rosà, tra le figure più significative, che si è espressa nella scrittura, nelle parole in libertà, nel disegno, nella ceramica e anche nella pittura. Di origine austriaca e nobile, il suo vero nome era Edith Von Hynau, frequentò i grandi artisti, Klimt, Beardsley, Toorop. In una crociera conobbe il giornalista italiano Ulrico Arnaldi che sposò trasferendosi a Roma. Durante la guerra, mentre gli uomini erano al fronte, Rosa Rosà scriveva: “Inutile ripetere che in questo istante milioni di donne hanno assunto- al posto di uomini – lavori che finora si credeva solo uomini potessero eseguire – riscuotendo salari che finora il lavoro onesto della donna non mai saputo ottenere”.
Alcuni suoi temi anticipano il femminismo degli anni ’70. Tra le europee ricordo l’inglese Frances Simpson Stevens, trasferitasi a Firenze con il marito nel 1907, con il quale l’unione fini nel 1913. Rimasta sola con tre figli, usci dalla depressione frequentando il caffè le Giubbe Rosse, dove si riunivano Soffici, Carrà e lo stesso Marinetti. Le sue composizioni artistiche furono apprezzate da Duchamp, Man Ray, che la fotografò più volte, mentre lei ritrassse Brancusi, Freud, Joyce, Marinetti, Papini.

un ritratto di Eva Kuhn
Impossibile in questa cartografia delle donne che hanno rappresentato l’avanguardia non parlare di Eva Kühn, moglie di Giovanni Amendola e madre di Giorgio, il futuro dirigente comunista, di Růžena Zátková, signora X futurista, di Tina Modotti. Eva, nata a Vilnius in Lituania, era poliglotta: parlava russo, inglese, francese, tedesco e italiano.
Da giovane si innamorò di Schopenhauer che per lei divenne il vero maestro. Dopo i soggiorni a Londra e a Zurigo, vinse una borsa di studio con un saggio sul filosofo statunitense Henry Thoreau, il teorico della disobbidienza civile e della resistenza non violenta. Con questa somma si trasferì a Roma dove conobbe Giovanni Amendola, di estrazione sociale modesta. I genitori di lui impedivano il matrimonio e Eva soffrì di una brutta depressione che la contrinse al manicomio di Via della Lungara dove fu ricoverata per un anno, dal 1904 al 1905. Ritornata a Vilnius, Giovanni andò a farle visita, ma poiché la madre di lei, questa volta, non lo volle vedere ritendolo causa della depressione della figlia, i due giovani raggiunsero Berlino e poi Lipsia dove entrambi frequentarono un corso di filosofia. Finalmente tornati in Italia, Giovanni aveva trovato lavoro, poterono sposarsi. Nonostante la sua intensa vita familiare e due figli, Eva entrò in contatto con l’ambiente di La Voce e Prezzolini le offrì la traduzione di Dostoevskij, mentre Papini le affidò Schopenhauer. Tra le sue frequentazioni vi era Teresa Labriola, la femminista che più tardi teorica di un femminismo nazionalista, Giacomo Balla, Sibilla Aleramo per cui il marito perse la testa. Eva divenne futurista con il nome di Magamal, nome che si rifaceva alla figura di un giovane guerriero africano di cui parla Marinetti in Mafarka il futurista. Scrisse Eva la futurista che non fu mai pubblicato, nel 1916 riuscì a pubblicare Velocità composto secondo la tipografia furista ispirandosi all’idea di simultaneità tra moto interno e moto esterno di Boccioni. Ormai anziana scrisse un inedito La pazzia e la riforma del manicomio a firma Eva Amendola, dove esprime la proposta di una riforma radicale delle case di cura, ovvero l’abolozione del sistema coercitivo dei manicomi.
Růžena Zátková è invece ceca, di Praga. Sposata con il nobile russo Vasilij Chvos̄o︣inskij, diplomatico zarista a Roma, fu amica e collega di futuristi italiani, Marinetti, Balla, Boccioni, Benedetta Cappa, Prampolini, per non dire del legame che la univa agli e alle intellettuali e artisti russi del suo tempo. Giovane pittrice, morì a soli 37 anni di tubercolosi. Nella sua arte si possono notare sia opere del primitivismo e del folclore che costituisce il dato autoctono dell’avanguardia russa, dall’altra il richiamo al futurismo italiano che , a sua volta, ha esercitato un’unfluenza sul cubo-futurismo dei russi.
Infine per concludere il suo interessante lavoro, Claudia Salaris dedica pagine molte belle a Tina Modotti, nata a Udine, ma presto trasferitasi in Messico dove ebbe rapporti di amicizia intensa con Frida Khalo e Diego Rivera. Fotografa, comunista, impegnata sia a livello artistico che politico, ha lasciato un patrimonio di opere d’arte, di scritti e disegni. L’incontro che cambiò la sua vita fu quello con il pittore Raubaix de L’Abuie Richey, detto Robo, a cui dedicò il Book di Robo.

Tina Modotti

Tina Modotti
Il periodo trascorso insieme a lui a Los Angeles dal 1917 al 1922 rappresenta per la giovane il confronto con il mondo intellettuale: il poeta e archelogo Ricardo Gómez Robelo, il critico d’arte giapponese Sadahiki Hartmann e il fotografo Eduard Weston che diventò il suo amante, attraverso il quale riuscì a diventare una professionista. Insieme ad altri artisti messicani diede vita ai murales che anticipano la street art. Ma da sola, non da altri, imparò a vedere il mondo degli emarginati con una comprensione che l’avrebbe portata verso la militanza politica. Nel 1927 si iscrisse al partito comunista messicano dopo l’esecuzione dei due anarchici Sacco e Vanzetti. Fu quello il periodo d’oro dell’attività politica e creativa. Tina tocca l’apice della carriera nel 1929 con l’esposizione organizzata dall’Università nazionale che rappresenta per lei l’ultimo atto pubblico in Messico. Nel febbraio del ’30 si imbarcò su una nave da carico olandese, diretta in Europa, dove sei anni più tardi sotto il nome di Maria, insieme al suo compagno Carlo Contreras partecipò alla guerra civile spagnola. Dopo varie vicissitudini, riuscì a tornare in Messico ma non riprese più in mano la macchina fototografica; Morì a soli 46 anni, nel gennaio 1946 per un arresto cardiaco. Attorno alla sua vita romanzesca, è nato un mito, continua ad alimentare iniziative e interesse dando vita a biografie, mostre, saggi. La sua rimane una vita fuori dai canoni.
A completare il lavoro di Claudia Salaris, molte foto di repertorio sia delle artiste che dei loro lavori più significativi. Un libro da non perdere.
Testo e immagini riprese da https://www.bibliovorax.it/2021/07/23/claudia-salaris-donne-di-avanguardia/