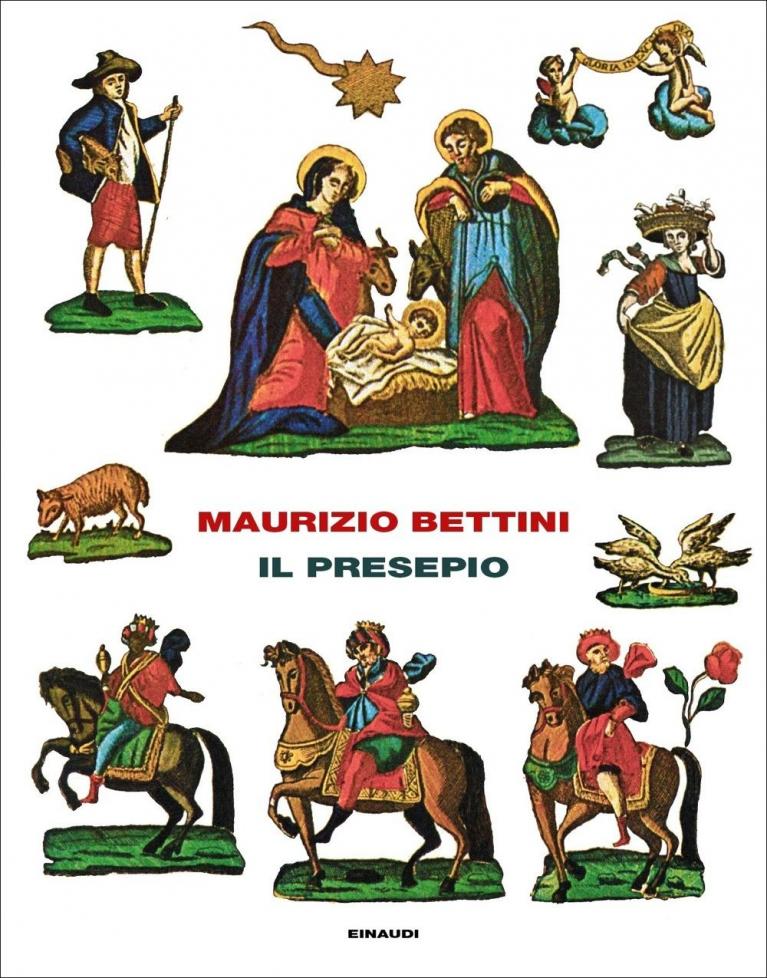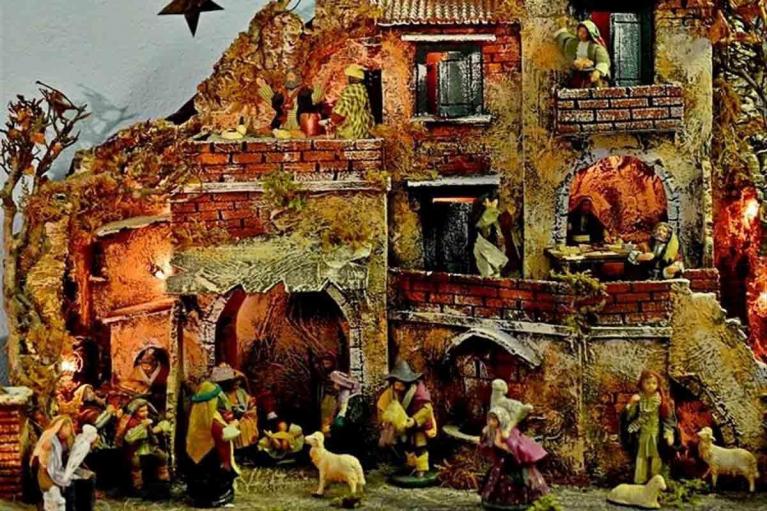Mentre sindaci, dirigenti scolastici, deputati e senatori
della ex Lega Nord, ora Lega di Salvini, e altri personaggi consimili,
tutti membri di diritto dell’eterno Carnevale italiano, si agitano per
riaffermare la presenza del Presepio nelle scuole e nei luoghi pubblici,
dal momento che in virtù del “politicamente corretto” vi è stato
estromesso, esce un bel libro dove la storia del presepio è raccontata
per filo e per segno. Che cos’è esattamente il presepio? Come nasce?
Perché ci sono quei personaggi? Che senso ha farlo oggi? Sono tante le
domande che s’affollano in questo libro del classicista Maurizio
Bettini,
Il presepio (Einaudi, pp. 189, € 19). Il suo non è
solo un libro di studio, ma anche un libro di memoria. Meglio:
un’autobiografia in forma di studio e di racconto. Tutto comincia con
una dichiarazione ad apertura di volume: “Non saprei dire da quanti anni
ho smesso di fare il presepio. Venti, trenta, anzi molto di più”.
Perché interrogarsi oggi su questo “oggetto” tanto da scrivere un libro
dotto e complesso? La risposta non viene subito. Prima bisognerà
intraprendere un cammino, per quanto una definizione l’autore la dà
subito: il presepio è “una finzione fragile, per questo incantevole”.
Seguiamo Bettini. E tenere bene a mente che la parola che l’autore usa,
sin dall’esergo infantile, è “presepio” e non “presepe”.
La fonte principale sono naturalmente i Vangeli. Si comincia con
Matteo (Matteo 2: 1 sgg). La storia è quella della nascita di Gesù a
Betlemme al tempo d’Erode. Ci sono i Magi che vengono dall’Oriente, che
passano a chiedere a Erode, il quale si fa promettere segretamente che,
trovato il bambino, torneranno da lui a riferirgli. I Magi, il cui
numero non è definito, seguono la stella, trovano il luogo in cui è
deposto il bambinello ma, avvertiti in sogno, fanno ritorno al loro
paese per altra strada senza parlare con Erode. Una storia che abbiamo
letto molte volte. Bettini ci fa notare che nel passo non ci sono
mangiatoie, pecore o pastori. Da dove spuntano fuori?
Il Vangelo di Luca (Luca 2: 6 sgg) è il vero testo che ha favorito la
nascita del presepio, anche se non subito. Lì c’è la mangiatoia, poi i
pastori, l’angelo, Maria, Giuseppe, ma non ancora i Magi. Non c’è
neppure la grotta, presente in molte iconografie successive, in quadri e
affreschi. A contribuire alla costituzione del presepio è un altro
testo, il Protovangelo di Giacomo, non entrato tra i canonici. Vangelo
apocrifo, ma molto influente presso le prime comunità cristiane, è stato
composto nel II secolo; è il Vangelo dell’infanzia di Gesù, da cui
provengono molte storie sul bambino divino. La vicenda del presepio
trova lì una serie di dettagli significativi. Il testo ha un andamento
narrativo; fa parlare i personaggi, compresa un’ostetrica, che aiuta
Maria a partorire. Lì si trovano il bue e l’asino, fondamentali per ogni
presepio che si rispetti, e anche i Magi. Di questa versione all’autore
del libro interessa la presenza della grotta. Gesù nasce lì, non in una
casa come in Matteo.
Questa la partenza. Per diventare un vero presepio deve attraversare
un altro terreno occupato dai teologi e dai commentatori delle sacre
Scritture. Il primo che ci interessa è Origene, anche se ci sono altri
prima, compresi eretici come Celso. Origene dà forma canonica al tutto:
Betlemme, la grotta, le fasce, la mangiatoia. Il punto su cui si
concentra Bettini da antichista, è il parallelo tra Gesù e le figure
mitiche che l’hanno preceduto: le storie delle nascite dei bambini
divini. In particolare Adone, che sembrerebbe fungere da modello per la
nascita dello stesso Salvatore. Inutile dire ci sono innumerevoli
paralleli e anche molti dettagli simili tra tutte queste storie,
compresa la grotta in Arcadia sul monte Cillene in cui è posto Adone. E
poi c’è la storia della nascita di Dioniso stesso.
I commentatori cristiani hanno sovrapposto le tradizioni pagane a
quelle del nuovo Dio e fatto slittare i significati dalla tradizione
passata al nuovo evento mitico narrato dai Vangeli, e commentato dagli
esegeti. L’autore si concentra sul termine “mangiatoia” per via di
questa sovrapposizione di storie:
líknon è l’oggetto greco che corrisponde al nostro “mangiatoia”; i Romani lo chiamano
vannus,
ed è il cesto utilizzato per vagliare il grano. Il viaggio che Bettini
ci fa fare tra le parole e le cose è affascinante; ci mostra la
parentela tra i miti greci, e poi romani, e il mito cristiano, tra le
nascite divine e quella di Gesù a Betlemme.
Luca indica la mangiatoia come un “segno” dato ai pastori per
riconoscere il Salvatore, cosa non indifferente, perché lo scambio dei
bambini è un topos sempre presente nelle storie mitiche, come racconta
la proto-saga di Harry Potter,
Animali fantastici, ora nelle
sale cinematografiche. Conclusione di questo primo tragitto: il mondo
antico è ricco di racconti in cui c’è un bambino nato in una grotta in
circostanze eccezionali, deposto non in una culla, bensì in un
contenitore differente. Si pensi alla vicenda di Mosè per restare alla
tradizione ebraico-cristiana.
Gli animali rivestono qui un ruolo non secondario:
Animali soccorrevoli
s’intitola il secondo capitolo del libro. A partire da Gilgamesh sino
ad arrivare a Romolo e Remo, e quindi Gesù, sono gli animali a
soccorrere il fanciullo divino, il predestinato a grandi cose; una
tradizione che nel mondo antico ha conosciuto una grande fortuna. L’eroe
bambino è rifiutato dalla cultura e salvato dalla natura, scrive
Bettini. Come entrano nella storia della nascita di Gesù l’asino e il
bue? Attraverso Virgilio. Mi si perdonerà se qui sarò breve, perché
Bettini, che è lettore ed esegeta acutissimo dei testi, non fa mai salti
in avanti: procede calmo e sicuro, e vaglia pazientemente tutte le
fonti che incontra.
Siamo nella quarta egloga delle
Bucoliche con un vaticinio a
lungo commentato, che ha portato Virgilio a entrare nel poema dantesco
quale guida e mentore. Diamo per scontato anche il passo profetico
redatto dal poeta latino; e qui non posso che rimandare alle pagine del
libro, così come per la storia di Costantino. In breve: Virgilio sembra
anticipare la venuta del Bambino divino, di Gesù, o almeno così può
essere interpretato il passo cui si fa riferimento nel libro. Tutta
l’antichità cristiana l’ha detto e ridetto, compreso il vaticinio
cumano, quello della Sibilla, presente in pitture e intarsi marmorei.
Arriviamo così a Prudenzio (348-402). In una raccolta intitolata
Odi quotidiane parla
del Natale di Gesù e degli animali (“i bruti animali”). Arrivano i
quadrupedi alla mangiatoia. Bettini ci mostra almeno un paio di
sarcofagi cristiani con natività dove sono raffigurati i Magi. Per
riassumere e per non perderci in questo che è solo un condensato
sommario delle pagine di
Presepio, diciamo che le due
tradizioni narrative della nascita del Salvatore (Luca e Matteo)
confluiscono in un unico racconto visivo. Il passaggio è importante: è
un racconto visivo. Il presepio, non bisogna mai dimenticarlo, è prima
di tutto un fatto visivo. Possiamo aggiungere: una piccola scultura
fatta di tante piccole sculture. Per usare un termine contemporaneo, che
non so quanto adeguato, e che Bettini certo non usa, il presepio è un
evento performativo. Non siamo al “dire è fare” di J. L. Austin, ma
neppure troppo lontani.
Sono le immagini delle opere d’arte (affreschi, bassorilievi, pitture
su tavola) che rendono visibile il presepio: dalle parole all’opera.
Siamo in quella che Bettini chiama la “memoria culturale”; il suo libro
s’iscrive all’interno di quest’area. Tuttavia senza le parole non ci
sarebbero queste immagini. Non le immagini in generale, ma proprio
queste. Da qui comincia il presepio propriamente detto: con bambino
nella mangiatoia, il bue e l’asino, i pastori, i Magi, con Maria e a
volte anche Giuseppe, ma non sempre. I due animali costituiscono un
punto importante, come si vedrà poi con San Francesco. Le fonti sono
affreschi: nelle catacombe romane e a Verona nell’Ipogeo di Santa Maria
in Stelle.
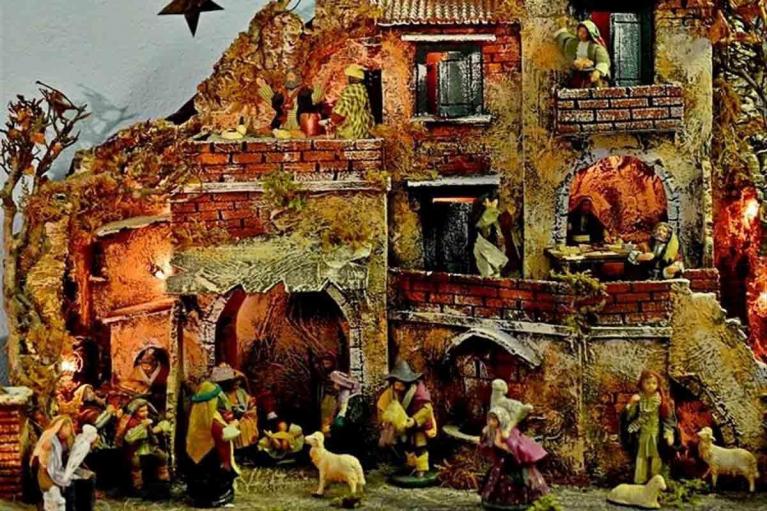
Bettini, da quello che si apprende leggendo il libro, ci ha messo
anni per mettere insieme le cose che racconta e spiega. Non tanto, e non
solo, le informazioni; i pezzi c’erano già, per quanto separati. Quello
che più conta in questo volume riccamente illustrato sono le
motivazioni di fondo, cioè le domande più o meno esplicite che Bettini
fa al suo presepio anche se non lo allestisce più da anni; l’ha fatto
nel passato e questo, come si vedrà, è quello che conta.
C’è un altro passaggio importante che chi ha fatto il Liceo classico
darà per scontato, ma che chi proviene dallo Scientifico o dagli
Istituti Tecnici e dall’Artistico non è detto colga al volo. Si tratta
del passaggio dall’allegoria al racconto. Oggi anche i ragazzini delle
medie inferiori sanno cos’è l’allegoria. Senza allegoria non si capisce
la letteratura medioevale, ma soprattutto le Sacre Scritture. La grande
tradizione allegorica sta alle nostre spalle, eppure, in qualche misura,
anche davanti a noi.
La mangiatoia non è mai esistita, dice Bettini, eppure è diventata
importante grazie al suo contenuto allegorico; di più: grazie alle
allegorie dei commentatori. Tutto un fatto di parole: “dire è fare”; da
“mangiatoia” si arriva a “greppia”, poi a “recinto”; “presepio”
significa esattamente “recinto”, ciò che si “chiude davanti”, come una
“siepe”, e questo è lo spazio dove stanno gli animali. E l’allegoria?
Origene è lui che porta dentro la storia del presepio gli animali. Cita
Isaia 1, 2: “il bue riconosce il suo proprietario e l’asino la
mangiatoia del suo padrone”. Un passaggio che Origene lega strettamente a
Gesù il Salvatore. Il gioco è fatto: uso allegorico e esegesi del
passo. I due animali entrano in scena.
La parola “presepio” c’è già nella traduzione di Isaia. Sant’Ambrogio
ne è il mediatore. Ciascuno porta il suo pezzetto e tutti insieme
creano il presepio. Tralascio alcune cose molto interessanti, che
riguardano la presenza o l’assenza di Maria, dei pastori e dei Magi.
Gregorio di Nissa spiega la presenza di tutti o quasi i personaggi in
questa scenografia natalizia della natività.
Bettini dice una cosa molto importante, che riguarda un’espressione
oggi in uso, seppure inflazionata, e quindi in progressivo
deprezzamento:
storytelling. Dice che dai testi si arriva al
racconto. Forse era già implicito, o almeno lo è per chi ha considerato i
Vangeli dei racconti. Non è sempre stato così. Aggiunge anche un’altra
osservazione che aiuta ad afferrare come funzionano le fake news: i
testi falsi o falsificati nella storia della cultura sono quelli che
esercitano la maggior influenza sulla memoria e sulle tradizioni. Questo
è il succo della storia del presepio: una tradizione inventata in un
lasso di tempo lungo, seguendo linee di sviluppo per nulla scontate:
caso o necessità? Entrambi, direi.
C’è ancora un altro partecipante al rito del presepio, partecipante
al plurale: i Re Magi. Arrivano il 5 gennaio, o almeno così dovrebbe
essere, in ogni presepio che si rispetti. Qualcuno comincia a metterli
prima, e poi li avvicina, progressivamente alla capanna, o grotta, il
giorno fissato: Epifania. Qui ci sarebbe un altro punto interessante da
sviluppare: la Befana. Non sto però qui a farlo. Basta ricordare che si
tratta di tradizioni che si sovrappongono o divergono, come per la
storia di Babbo Natale. La cultura è sempre ibridazione.
C’è una tradizione che sostiene che l’arrivo dei Magi sia legato alla
identità taumaturgica di Gesù; i miracoli sono il risultato di una
investitura, o riconoscimento, che avviene grazie a loro. Come nelle
teorie del complotto – il paragone non appaia irriguardoso – si cerca di
far collimare cose diverse, di fonderle insieme; qui è la nascita e le
profezie bibliche; è il caso di Isaia citato. In Matteo il ruolo dei
Magi è decisivo e non è solo legato a una questione astrologica come
qualche volta è stato detto.
C’è un’opera esemplare di tutto questo: i Re Magi che compaiono nel
mosaico ravennate di Sant’Apollinare Nuovo, realizzati nel VI secolo.
Una meraviglia: mantelli, doni, postura, volti, berretto frigio: tutto
questo vale da solo il viaggio nella città romagnola, antica capitale.
Ora, come mai i Magi sono diventati tre, mentre in Matteo erano plurali,
di numero non definito? E poi perché sono dei re? Rimando alle pagine
di Bettini, anche se non esauriscono una storia che da sola meriterebbe
un libro a sé. Chissà che l’autore di questo libro non la scriva prima o
poi.
C’è un testo di un cristiano alessandrino vissuto tra il V e il VI
secolo che risalirebbe a un monaco della corte merovingia, una storia
avventurosa essa stessa:
Excerpta Latina barbari; qui vengono
finalmente dati i tre nomi ai Magi: Bithisarea, Melchior, Gathaspa. E il
Re Mago nero? E perché in alcuni dipinti figurano un vecchio, un
giovanotto e un nero? Risposta di Bettini: la macchina narrativa produce
dettagli e notazioni che arricchiscono man mano il racconto. Chi ha
letto Propp lo sa. Meraviglia del narrare! Quello che fa specie
all’autore di questo volume è che all’origine di tutto ci sia la
“lambiccata opera dei teologi”, dal che si capisce che Bettini, pur
avendo studiato dai gesuiti, come racconta, non ami le lambiccature. E
qui sta probabilmente il cuore del suo libro.
Prima di spiegarlo bisogna andare a Greppio, al presepio vivente di
Francesco. Il santo crea il presepio come dal racconto di Tommaso da
Celano. La faccio breve, per quanto esista sulla storia un’ampia
letteratura da cui, pur conoscendola, Bettini prescinde. Il centro di
questo imprescindibile episodio, da cui verrebbe il nostro presepio
attuale, c’è una assenza. Mancano il Bambino, Giuseppe, Maria, i pastori
e agli angeli. A Francesco interessano il bue e l’asino in carne e ossa
da mettere vicino alla mangiatoia. Questo è il
focus del
praesepium:
il fieno contenuto. Possibile? Sì, il santo mette al centro
dell’attenzione un oggetto. Non vuole raccontare l’intera vicenda della
Nascita, scrive l’autore, come si è creata nella tradizione cristiana
sin lì. Si prefigge di mostrare, di far vedere con gli occhi del corpo i
disagi che Gesù ha dovuto affrontare sin dalla sua nascita: mangiatoia,
fieno, asino e bue a riscaldarlo. Il resto non gli importa.
Qui è il centro della ricostruzione di Bettini: il
praesepium è il fulcro della storia. La “cosa”, non la scena, viene da dire. Gli interessa la traccia linguistica –
líkna – che ha inseguito in tutto questo lungo percorso come un detective.
A questo punto, siamo al capitolo terzo del libro, intitolato
Un’antropologia del presepio,
Bettini capisce di non aver “capito” il presepio. Il suo flusso di
memoria culturale sì, ma non “la cosa”. Che cos’è “la cosa”? Il
presepio, scrive, è un artefatto, posto al centro di un rituale,
culturalmente significativo. Tuttavia ha perso il suo significato
originale, quello su cui lavoravano i teologi e gli esegeti. Necessita
qualcosa che Bettini non ha più – dice di averlo avuto, ma che non l’ha
più da decenni.
Qui il libro cambia tono e ritmo. L’autore narra di aver visitato
tanti presepi alla ricerca dell’essenza del presepio stesso – questa
espressione è mia. A Pisa, a Firenze, a Parigi, alle Cinque Terre, a
Bressanone. Racconta di presepi magnifici, anche se le sue descrizioni
sono sempre un po’ malinconiche. Rientra a casa e conclude: il vero
presepio è quello che si fa per conto proprio, nella propria
abitazione.
Queste considerazioni gli danno l’occasione di dire cosa è il
presepio. Siamo nel campo dei significati, non delle origini e neppure
delle spiegazioni. Il presepio è il ciclo del tempo; ha una natura
fiabesca; implica degli spettatori che non sono dei creatori. Bettini è
innamorato dei personaggi del presepio, quelli introdotti
successivamente. Sono pagine molto belle, sognanti. Lo studioso ha
lasciato qui il passo allo scrittore, al sognatore del presepio.
Il presepio contiene più temporalità: il tempo narrativo, il tempo
mitico e il nostro tempo. In realtà questi tempi si fondono insieme e
solo lo studioso, l’esegeta della “cosa” presepio riesce a vederli e
distinguerli. Tutto sta nella temporalità che si vive. Quella sacra è
stata fondamentale per secoli. E oggi? Per arrivare alla conclusione,
che in realtà è lì, a pochi passi da lui, Bettini deve rivestire i panni
dello studioso e raccontarci un’altra storia, quella dei Sigillaria, le
feste del dio Saturno a Roma. Non starò a raccontare anche questo
passaggio. Rimando al libro e vi assicuro che ne vale la pena. C’è
ancora un altro passaggio, quello che riguarda i Lari, i protettori
della casa. Sono storie di statuine, di piccole sculture di terracotta,
presenze del passato. C’entrano con Gesù, spiega l’autore. Sono presenze
dell’assente, gande tema religioso, sia pagano che cristiano.
Corro alla fine, là dove c’è la risposta ai tanti perché di questo viaggio nella storia e nell’antropologia del presepio.
De te fabula narratur.
Perché mi occupo del presepio?, si chiede l’autore. Perché ho un patto
di fedeltà nei confronti di me stesso. Non quello con la religione in
cui sono stato allevato, il Cristianesimo – Bettini ha scritto vari
libri per manifestare la “superiorità” del politeismo sul monoteismo. La
fedeltà a se stessi è quella all’infanzia, alla propria infanzia. Il
presepio, non è solo l’infanzia della Divinità, che ha dominato la
nostra storia occidentale per due millenni, ma proprio l’infanzia di
Maurizio Bettini, e il presepio è il ritorno al proprio Io bambino.
Riguarda quel tempo, che non è passato, ma continua ancora, ogni volta
che si fa il presepio. Un tempo mitico, si dovrebbe dire, perché anche
questa temporalità fuori dal tempo, per quanto diversamente dal passato,
oggi la pratichiamo ancora, in tutto ciò che è sospensione del tempo
feriale dominante, nel tempo della festa, nelle mitologie del
contemporaneo e ancora, per nostra fortuna, come ci fa capire Bettini,
nel presepio. Non sarà molto, tuttavia non è neppure poco.
Testo ripreso da:
https://www.doppiozero.com/