La lezione della rotta atlantica degli schiavi
Gian Andrea FranchiC’è un legame fortissimo che troppi non riconoscono o mettono in ombra tra l’antica schiavitù, il colonialismo, il postcolonialismo – dominato da nuove forme di violenza e di mercificazione della vita – e le migrazioni destinate a crescere in tutto il mondo. Secondo Saidiya Hartman, autrice di Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi possiamo trovare speranza nei sogni di coloro che oltrepassano i confini, nella loro capacità di cercare mondi non identitari e liberi dalla violenza dello Stato

Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi, di Saidiya Hartman, docente alla Columbia University, è un libro singolare. Meditazione personale, storico-politica e filosofica trapassano continuamente l’una nell’altra. Una scrittura colloquiale e insieme meditativa riesce a tracciare, con quell’apparente leggerezza che è talora il segno della profondità, il senso comune a questi orizzonti emotivi e di pensiero alla luce nera della schiavitù.
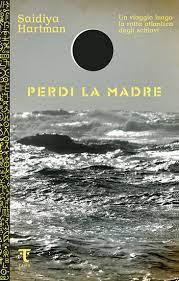
La schiavitù è il buco nero di non approdo della “mia sete … di passato”, scrive Saidiya, il cui nome è africano. La schiavitù è sempre stata l’abisso nella riduzione dell’essere umano a cosa: dagli antichi imperi al capitalismo, in cui tale riduzione diventa quella dell’essere umano a merce, ormai condizione universale bio-geologica nell’allargamento a tutta la terra che, se non fosse diventata per tutti (o quasi…) la normalità (la normalizzazione), dovrebbe farci scoppiare d’angoscia.
Il libro tratta della questione del “prima” e del “dopo”, cioè del tempo storico e personale, di una discendente di africani venduti schiavi negli Stati Uniti, in cerca di quello che non può trovare:
“un’identità collettiva panafricana preesistente al disastro collettivo della tratta degli schiavi”. “La schiavitù aveva reso il passato un mistero, sconosciuto e indicibile” (47).
Saidiya dovrà scoprire che i poteri africani dell’epoca, ma anche intere popolazioni, erano pienamente corresponsabili della tratta.
La scrittura è il mezzo principale per elaborare il tempo, per dargli, cioè, un senso, per tracciare una continuità tra passato, presente e futuro e per lasciare traccia del proprio passaggio a chi rimane e verrà dopo di noi e affrontare quindi l’ignoto del futuro e la necessaria scomparsa come unità biologica cosciente.
Con questo libro, frutto della sua “sete di passato”, Saidiya Hartaman cerca di elaborare la sua condizione di cittadina statunitense nera, discendente di schiavi. Nello stesso tempo, necessariamente, è spinta ad affrontare la condizione storica in cui si è formata la schiavitù moderna.
Da questa sofferta ricerca derivano riflessioni che saldano l’antica schiavitù, alla fase coloniale, alla nuova condizione degli africani:
”Alla radio i ghanesi dibattevano se sotto il colonialismo non fossero stati dopotutto meglio. I programmi di aggiustamento strutturale e le iniziative dei paesi debitori orchestrate dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale erano la nuova schiavitù” (65).
La delusione del non ritrovare in Africa le proprie radici trova compensazione in una sofferenza che si trasforma in pensiero: “l’appartenenza” come “l’oblio di sé”: “indipendentemente da dove andassi sarei sempre stata una straniera appostata fuori casa. E questa interminabile condizione – ‘la nudità astratta dell’essere uomini e nient’altro che uomini’, per prendere in prestito le parole di Hannah Arendt – non c’era luogo in cui fosse più evidente che in Ghana” (67),
cioè nel paese di sbocco della grande schiavitù atlantica, in cui Aidiya trascorre un anno di ricerca.
La ricerca dell’appartenenza si trasforma nella dolorosa, sempre incerta perché contraddittoria, meditazione che la non appartenenza – “l’essenza della schiavitù” – ha a che fare con l’amore:
“Questo senso di non appartenenza, di sentirsi un elemento estraneo, è l’essenza della schiavitù. L’amore non c’entra nulla con questo; l’amore c’entra eccome”.
Appare qui la contrapposizione fra due significati della parola “amore”: frutto della dolorosa esperienza del suo viaggio e lungo soggiorno in Ghana. Il pensiero fatica ad accogliere il sempre contraddittorio vissuto della non appartenenza: l’amore come appartenenza, amore limitato, possessivo, individualistico, chiuso ai non appartenenti: amore familiare, di gruppo, di etnia, al limite, di nazione – quello che cercano i discendenti degli schiavi; e l’amore in un senso ampio e collettivo come vivere quale parte attiva ed essenziale di un tutto in cui ci si sente e si è liberi, accolti e vicini a tutti e a ciascuno.
Questo vissuto, che lentamente si trasforma in pensiero, ha nel libro uno sbocco finale con la visita alle povere rovine di Gwolu, uno dei centri di resistenza e lotta di coloro che, ricercati dai cacciatori indigeni di schiavi, riuscirono a resistere contro le bande armate dei predatori, sconfiggendole.
“Il sogno del fuggitivo oltrepassava i confini del continente: era un sogno del mondo come casa. Se c’era una cosa che avevo imparato a Gwolu, era che le vecchie identità … devono essere lasciate andare per inventarne di nuove. La tua vita potrebbe dipendere da questa capacità di auto-creazione […] Era il sogno di un altrove, con tutte le sue promesse e i suoi pericoli, dove i senza-stato potessero finalmente prosperare” (286-87).
Da ciò Aidiya ricava la speranza di un possibile movimento storico verso una società e un mondo non identitari, non statuali, ma – possiamo dire – fondati nella collettività: essere-con-gli-altri, essere come con-essere.
“La speranza è che il ritorno possa […] trasformare la sconfitta in una vittoria, e dare origine a un nuovo ordine. […] La perdita ti ri-crea”. “Quelli che non credono alla promessa” del ritorno in una terra natale “non hanno altra scelta se non accettare quella perdita che inaugura l’esistenza. Ed essere legati ad altre promesse. E perdere la madre, (per) sempre” (129).
Con ogni evidenza, infatti, lo Stato, ogni Stato – gli Stati postcoloniali africani, lo Stato imperiale nordamericano… – è basato sulla violenza: la violenza del “decidere se devi vivere o devi morire” (286): ciò che Judith Butler chiama stabilire la “dignità di lutto”. Aidiya cita Foucault: “Il razzismo è distribuzione sociale della morte” (163): dobbiamo aggiungere, però, anche il classismo. Lo vediamo con i nostri occhi anche nelle attuali migrazioni attraverso il Mediterraneo, i Balcani… La violenza di Stato è intrinsecamente schiavistica, in forme più o meno dirette o nell’ormai universale forma della mercificazione. Oggi, infatti, è in atto una forma sottile, impalpabile, aerea, di schiavizzazione dolce, soporosa, in cui ha gran parte l’elettronica. Innumerevoli forme di schiavitù aleatoria, variabile, ma proprio per questo molto più efficace, sono il fondo della mercificazione della vita intera sulla terra, che sta giungendo al biocidio. Questa mercificazione dell’umano e del vivente, oggi, non riguarda tanto “la produzione fisica di merci quanto piuttosto l’appropriazione” (Brancaccio e altri, La guerra capitalistica, Mimesis, 2022), in mano ai centri di potere finanziario controllati da un numero esiguo di individui. L’appropriazione è, in ultima analisi, il potere sulla vita attraverso la sua mercificazione – o piuttosto l’illusione, la follia violenta, del potere sulla vita, sulla nuda vita (Agamben, Canetti, Massa e potere, 1960).
In diversa ma significativa misura, anche le attuali migrazioni – dall’Africa verso l’Europa, attraverso i Balcani dal Medioriente e dall’Oriente e dal Sudamerica verso il Nord, con alto prezzo di vite, rientrano in questa violenza della mercificazione totale: i numerosissimi morti senza nome nel Sahara e in mare, anche nei Balcani, al confine fra Messico e Stati Uniti. Anche queste sono vite dell’altrove, sospese fra la patria abbandonata e rimpianta e l’irrealizzabile sogno occidentale in cui saranno, se non schiavi, manodopera sottopagata.
Sono tutte vite di scarto, a diversi livelli: anche quelle di chi muore sul lavoro o ha un salario inadeguato a vivere, l’aumento della povertà in Occidente: “Lo scarto è il residuo di tutte le vite che sono al di fuori della storia, ‘dissolte in un’amnesia totale“ (146). Lo scarto, le vite di scarto si stendono ovunque nel mondo attuale in cui il potere tende a una concentrazione estrema dei sistemi di appropriazione.
Ma la mercificazione della terra produce anche qualcos’altro che tutto raccoglie: la devastazione della terra, per l’estrattivismo e l’alterazione ambientale e per le guerre imperiali (Afghanistan, Iraq, Siria e oggi anche in Europa, quale premessa di un più vasto scontro che si delinea da qualche tempo a livello mondiale…).
Queste migrazioni sono anche l’annuncio che il futuro terrestre sarà sempre di più tempo di migrazioni dai moltissimi luoghi della terra che diventeranno inospitali e invivibili.
Il biocidio è ben noto. Appare, però, inimmaginabile, quindi impensabile, benché concettualizzabile con cifre, dati e riflessioni astratte. Proprio per queste sue caratteristiche, viene usato invece per addormentare la gente: troppo grande, troppo angosciante, per venir immaginato e articolato in un pensiero attivo che susciti reazioni e azioni.
Scriveva James Baldwin, a proposito della condizione dei neri, prima e dopo la schiavitù negli Stati Uniti:
“Non è ammissibile che gli autori della devastazione siano anche innocenti. È l’innocenza che costituisce il crimine” (citato da Aidiya, 210).
Questo ossimoro esistenziale e storico di colpevole innocenza è oggi, nell’Europa – per parlare solo del semicontinente in cui vivo – largamente diffuso tra la gente: il marchio della nostra attuale condizione storica.
Alcuni chiamano tutto questo “totalitarismo morbido” che si basa sull’impossibilità di fare esperienza, nel senso benjaminiano del termine, di immaginare e portare al pensiero e all’azione le condizioni reali della nostra vita. Quest’impossibilità è però legata anche alla enorme difficoltà di fare esperienza del biocidio in atto, un fenomeno assolutamente nuovo, che oscura il futuro.

Nessun commento:
Posta un commento